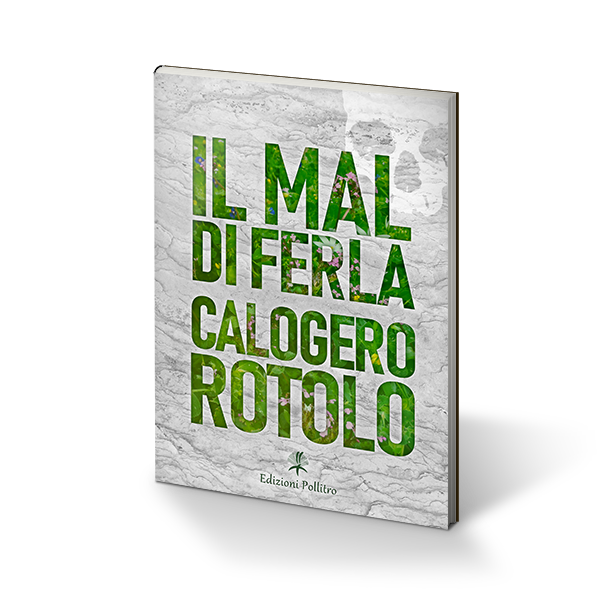
La “ferla”, o “ferula” in italiano, è una pianta erbacea perenne diffusissima nelle campagne dell’entroterra siciliano.
Tale pianta si presenta come un basso e soffice arbusto dalle foglie sottili e fittissime. Dalla distanza di pochi passi ha tutto l’aspetto di una nuvoletta verde, sospesa a un palmo da terra.
Non è raro, specie nei terreni incolti, trovarsi di fronte a intere distese di campi rannuvolati da ferule in gran numero.
Ad un certo punto della sua vita questo arbusto genera uno stelo verticale che presto s’ingrossa e rafforza fino a diventare un tronco alto diversi metri. Alla vertiginosa altezza sboccia un ramificarsi di fiori, anche questi minuti e fittissimi.
Il risultato ricorda incredibilmente le forme che certi fuochi d’artificio tracciano in cielo, quando da una scia luminosa principale divergono altre scie più piccole che terminano in una costellazione di esplosioni radiali. Lo stelo e i fiori della ferla sembrano immortalare tali fuochi al loro apice di luminosità ed estensione.
La ferla ha in sé un veleno con proprietà anticoagulanti. Se ingerita da uomo o animale può causare emorragie e condurre ad una rapida morte.
Tuttavia, sulle sue radici prospera un tipo preciso di fungo, il cui nome scientifico è “Pleurotus eryngii” della varietà “ferulae”, ma che i siciliani chiamano appunto “fungi di ferla”. Sono funghi commestibili e molto apprezzati in cucina.
***
«La prossima volta che mi rispondi così giuro che ti butto nel forno a cuocere con lo zolfo!» Il picconiere era un vero diavolo quella sera. Lampeggiava rosso in viso mentre lo straccio lercio, che teneva sempre avvolto in capo per raccogliere il sudore, si agitava come scosso dal vento. Alle solite sue terribili manate aggiungeva adesso dei calci vigliacchi sulle fragili costole di Totò, già deformate dai carichi della miniera.
«Un demonio siete! Un demonio d’inferno! Basta, voglio andare a casa mia!» Con le lacrime e il muco già impastati con la polvere di gesso e di zolfo, Totò pareva un vitellino che viene macellato e i suoi lamenti erano uguali a dei muggiti disperati.
Il villaggio dei minatori a quell’ora della sera poteva essere scambiato per un camposanto, tanto il silenzio era pesante. Dopo una interminabile giornata sottoterra, nessuno – caruso, picconiere o capomastro che fosse – aveva la forza di far nulla. Soltanto un uomo osceno come quello poteva avere ancora voglia di brigare coi poveri carusi.
I più piccoli lo chiamavano “Capo”, mentre i più cresciuti non lo nominavano se non con un “Bastardo” mugugnato tra i denti quand’egli era distratto.
Ciascun picconiere aveva potere di vita e di morte sui carusi che gli venivano affidati – acquistati come bestie da soma, né più né meno.
Per Totò e per i suoi compagni di sventura la Sorte aveva aggiunto un carico in più, premurandosi di farli capitare sotto il dominio di un’anima nera e schifosa come poche.
Nelle notti e nei giorni peggiori Totò arrivava a pensare che se l’Onnipotente aveva un naso, una bocca e due occhi come un cristiano, allora di sicuro quella faccia la girava sempre da un altro lato e al Capo non lo guardava mai per non vomitare.
«Quale casa e casa?! Sottoterra è la tua casa adesso. Di giorno sottoterra e di notte sotto a me!» La risata sporca del Capo dava più ritmo ai calci e alle manate. Risata di merda e mani di pietra.
Totò sapeva già dalla mattina che quella sarebbe stata una giornata di quelle brutte. Sotto il peso della cesta, carico di terra e pietre, aveva detto a mente l’unica preghiera che conosceva e l’aveva ripetuta per tutto il tempo “Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te…”
Ma adesso che il Capo lo aveva acchiappato e che lo teneva schiacciato nella polvere con tutto il peso del suo enorme corpo, Totò capiva che non era bastato tutto quel pregare… che non sarebbe bastato mai.
Il pianto del bambino aveva di sicuro svegliato tutti i minatori, eppure nessuno stava abbandonando il proprio giaciglio di fortuna per interrompere quello scempio.
Diego aveva stretto i palmi delle mani attorno alle proprie braccia per tutto il tempo, tanto da farsi male. Al misero riparo di una nicchia scavata sul fianco di un calcherone, ascoltava le urla e bruciava di rabbia. Prima che arrivasse in miniera Totò, per lunghissimo tempo era stato proprio lui la preda di ogni sera tra le dure mani del Bastardo.
Adesso era quasi un anno che non temeva più l’arrivo dello scuro dopo il lavoro. Tuttavia la vergogna e la sofferenza di quel povero caruso erano per Diego come i sassi nella cesta, lo schiacciavano e lo graffiavano e non riusciva a toglierseli di dosso in nessun modo.
All’improvviso ci fu un urlo più alto del solito e Diego si ritrovò a correre al buio e scalzo sulla ghiaia con in mano il manico spezzato di una zappa. “Ora l’ammazzo!”
Ma già dopo il primo colpo sordo calato sulla schiena dell’uomo, Diego si ritrovò anche lui steso a terra di fianco a Totò e il bastone, che poco prima stringeva con tutta la sua forza, adesso gli calava addosso come una frana nel fondo della miniera. «Bastardo, sei la merda della terra! La miniera ti deve ingoiare e non ti deve sputare più, cosa inutile!» Ma l’unico effetto delle maledizioni di Diego fu una maggiore violenza nei colpi del picconiere, forte della tecnica con la quale spaccava anche le rocce più dure.
Sfogata la furia, il Capo s’asciugò i sudori della fatica col disgustoso turbante e lasciò cadere il culo su di una cassa. «M’avete fatto stancare…» e guardandosi attorno come appena sveglio «Già così scuro è? Andate a prendermi da mangiare, sennò domani chi ce l’ha la forza di alzare il piccone!»
I ragazzini si aiutarono a vicenda a rimettersi in piedi, gonfi di botte e sporchi di terra e vergogna. Si allontanarono curvi, ma dopo manco un minuto Diego era già di ritorno con una tazzona di metallo al cui interno ondeggiava una zuppa annacquata, che il Bastardo quasi gli strappò dalle mani. «Minchia, fredda è!» E dopo un primo sorso, masticando qualcosa, aggiunse: «Fungi di ferla, come deve campare un uomo in questo modo? Asparagi, babbaluci e fungi… spendi grana assai e niente mangi…» La cantilena si spense in un secondo lungo e rumoroso sorso.
***
Era ancora notte fonda quando suonò la campana della sveglia. I carusi uscivano dalle loro tane come sorci spaventati. La squadra del Capo si radunò e attese il picconiere. Ma l’uomo tardava, quindi Diego si decise ad andarlo a svegliare. Non era raro che, per la stanchezza o per il vino, non sentisse la campana della chiamata.
Lo trovò sul suo pagliericcio, come sempre steso a pancia all’aria, eppure stavolta c’era qualcosa di diverso. Gli occhi dell’uomo erano spalancati verso il cielo. Dalla bocca emergeva la lingua abbandonata su una guancia. Il Bastardo ansimava e gorgogliava. Diego si avvicinò con lo stesso timore e la stessa cautela con i quali si approcciava a un randagio ferito.
Così vide che dal naso, dalla bocca e dagli occhi del picconiere grondavano rivoli di sangue scuro e in parte già secco. E anche la parte di stuoia che aveva sotto il culo era macchiata di sangue.
Eppure il Bastardo ansimava e parlava, anche se non si capiva nulla di quello che stava dicendo. Voltando il capo lentamente verso il ragazzino riuscì a pronunciare distintamente solo una frase smezzata: «Tu sei stato e io lo so e stai tranquillo che non me lo sc…» Seguì un rumore di pompa che tira fango anziché acqua e poi il silenzio.
Davanti agli occhi di Diego quel corpo gonfio divenne all’improvviso una minaccia più grande di quando era uomo vivo. Ebbe d’istinto la paura di essere portato via dalle guardie o qualcos’altro di indefinito e quindi peggiore.
Con mani tremanti afferrò gli angoli della stuoia ai piedi del morto e lo tirò giù dalla paglia, quindi lo trascinò ancora fino a raggiungere la discenderia vecchia. Il pozzo s’apriva su una caduta quasi verticale, tanto fonda che per raggiungere la fine ci voleva quasi un’ora per un caruso senza carico. Quando vi lasciò cadere il corpo del picconiere, lo vide urtare e rompersi sui ruvidi gradini spezzati. Diego seguì, con gli occhi prima e con le orecchie poi, la caduta fino a non avvertire più nulla.
Anche la paura era sparita, inghiottita dal buio sottoterra.
***
Visto che il Capo quel giorno non si fece vedere, i suoi carusi vennero affibbiati a un altro picconiere per non perdere la giornata di lavoro.
Totò diede un’occhiata perplessa a Diego, un attimo prima di imboccare il tunnel della solfara. Il ragazzo strinse le labbra fino a farle sparire in bocca e fece un cenno col capo verso l’ingresso della miniera.
Quando il Sole si alzò in cielo, loro erano decine di metri sottoterra già da diverse ore.
Difficile dire a che punto della giornata si era giunti quando ci fu il crollo. I carusi si trovavano in uno dei livelli più profondi della solfara e trasportavano il loro carico di terra fino a due livelli più in alto, non oltre. Per cui la luce del giorno non poteva raggiungerli.
A dirla tutta era da settimane che queste creature venivano inghiottite dalla terra col buio e col buio venivano risputate fuori.
Ci fu un tuono in lontananza, seguito da echi terribili. L’aria si riempì di polvere e grida.
Quando anche l’ultimo riverbero di quel terribile rombo si fu placato e le polveri rasserenate, Totò si accorse di essere vivo e libero da pesi. Sentiva le voci che dall’alto chiamavano e vedeva avvicinarsi delle luci in lontananza.
Ma voltandosi un attimo verso il fondo, una lampada ad acetilene caduta tra le rocce crollate, ma ancora accesa, gli mostrava il viso di Diego coperto di sangue. A poca distanza vide quelle che prima erano state le gambe e le braccia del ragazzo, ma che adesso erano solo poltiglia rossa e bianca che colava tra le pietre.
Eppure fu ciò che vide oltre il cono di luce della lampada, al di là dei cumuli della frana, a sconvolgergli la mente. Più dello spavento del crollo e più dell’orrore del corpo maciullato…
Una mano poggiava sopra le rocce. Era grande quasi come un bue e gravava il suo peso a schiacciare ancora di più quel che restava di Diego. Fuori dal cono di luce emerse, appena percettibile nella penombra, un bastone… no, non era un bastone, sembrava un enorme piccone… ma era ruvido e graffiato come le pareti della miniera e candido del colore delle ossa.
Quando la colossale mano e lo strano gigantesco piccone si mossero, come risucchiate verso il buio fondo della galleria, una nuova forma si scosse nell’ombra. A Totò mancò il respiro, perché gli sembrò di vedere uno sporco turbante ondeggiare sopra due grandi occhi di serpe.
***
Lo tirarono fuori dalla miniera reggendolo per le braccia e per le gambe, come un morto, anche se non era ferito. Lo portarono lontano e poi corsero di nuovo dentro a raccogliere gli altri compagni.
Totò si trovò a fissare il Sole a picco sul suo corpo nudo e impolverato. Lasciò che i suoi raggi gli scaldassero le ossa e quando sentì nuovamente la forza nelle gambe si alzò in piedi e corse via.
Si fermò un attimo ai piedi del calcherone dentro al quale aveva dormito da quando era arrivato lì. Nascosti sotto un mucchietto di sassi, dentro la sua nicchia per la notte, ritrovò i suoi miseri averi: un paio di calzoncini laceri, una canotta sporca, un piccolo marranzano, un pugno di mandorle con il guscio, due morbidi ciuffetti di ferla ancora verdi.
Ne fece un fagotto e, non visto da nessuno, s’incamminò verso casa lungo la distesa di mucchi di terra gialla e i camini dei forni sempre fumanti.
Fine | Torna all’indice di questo racconto
oppure
