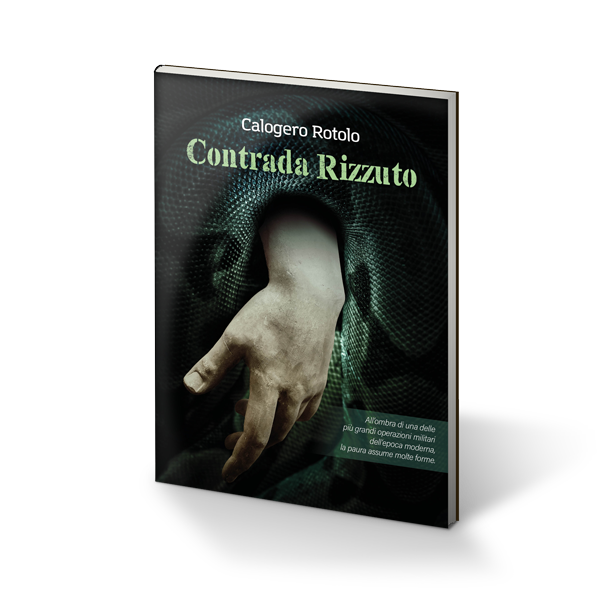
INDICE
Capitolo 1 – Capitolo 2 – Capitolo 3 – Capitolo 4 – Capitolo 5 – Capitolo 6
1
Anche se il mio corpo veniva scosso dal rapido avanzare dell’imbarcazione sulle onde e nonostante il freddo umido della notte in mare mi facesse battere i denti, riuscii per qualche minuto a distrarre la mia mente. Stavo sfogliando il piccolo libretto che ci aveva distribuito il maggiore la sera prima. Era come una guida turistica, anche se in realtà si trattava di una guida per la guerra.
Lo scopo di quell’opera infatti era informare noi soldati di tutto ciò che avremmo incontrato una volta sbarcati in Sicilia.
Saltai volentieri l’introduzione a firma Eisenhower e anche la parte dedicata alla storia dell’isola. Mi ero soffermato invece con piacere sul paragrafo dedicato alla natura di quella terra. Leggevo parole che mi illuminavano gli occhi, cancellando per un momento il buio e il freddo nei quali ero immerso e accendendo colori vivacissimi. Parole come “spiagge”, “limoni”, “arance”, “mandorle”, “olive” o addirittura “vulcano”.
Quanto avrei voluto essere un vero turista che si approcciava a visitare per la prima volta una bellissima terra straniera, e non un soldato semplice al centro di un’invasione armata!
Saremmo sbarcati poche ore prima dell’alba, di modo da sfruttare al massimo sulla terraferma tutte le ore di luce. L’enorme esercito dell’alleanza si sarebbe diviso su diversi fronti per lo sbarco. La nostra destinazione era il lembo di costa appartenente al territorio della città di Licata.
Non sapevo assolutamente niente di quei posti, per me quest’isola al centro del mediterraneo poteva benissimo essere grande come uno scoglio. Invece il libretto diceva di aspettarsi una regione delle dimensioni della Scozia. Non che avessi un’idea precisa di quanto grande fosse la Scozia, ma pensai che di certo piccola non doveva essere.
Da questi pensieri, diciamo così, geografici, mi strappò via Monroe con uno spintone. Non mi ero accorto che i motori dello scafo s’erano spenti e che l’imbarcazione adesso avanzava lenta, senza scossoni. Il segnale era chiaro: eravamo arrivati a poche decine di metri dalla riva.
“Questa è la nostra fermata, sir!” – mi gridò Monroe diritto dentro l’orecchio destro, buttandosi di peso sulla mia spalla.
Con Luke Monroe ci eravamo arruolati volontari insieme. Essendo cresciuti nello stesso isolato a Little Italy, nella parte meridionale del distretto di Manhattan, ci conoscevamo da sempre. Tuttavia, se devo essere sincero, non ci eravamo mai considerati nulla più che conoscenti. Di lui sapevo poca roba a parte che era uno di quelli che si vantano di picchiare la propria moglie. Soltanto la guerra ci aveva costretti ad una comunità d’intenti inedita. Cosa che Monroe scambiò forse per destino, così come scambiò la mia disinteressata educazione per amicizia sincera.
Ma con la guerra sul nostro cammino, ogni amico in più, anche se insopportabile come lui, era un qualcosa che poteva fare la differenza tra il tornare e il non tornare a casa. Per cui, senza mai sbilanciarmi in gesti d’affetto o smancerie che potessero confermare a Monroe un nostro rapporto di amicizia, mai gli diedi motivo di intuire quanto in realtà lo odiassi.
In quei giorni che avevano preceduto lo sbarco, Luke non era riuscito a nascondere il suo entusiasmo. L’idea di visitare finalmente la terra dei suoi genitori – era figlio di una coppia di Italiani, come quasi tutti a Little Italy – lo estasiava. Il cognome di suo padre era infatti Marrone, ma all’epoca il vecchio aveva voluto dare ai figli un tono più “americano”. Eppure adesso il fatto di essere un soldato alla vigilia di una guerra non riusciva a scalfire la smania del sangue italiano di Monroe.
Io, al contrario, non sentivo nessun richiamo nelle vene. Attribuivo quella mancanza di vibrazioni nei confronti di questa terra al fatto che i miei genitori non erano immigrati italiani, bensì erano figli di immigrati. La mia famiglia aveva lasciato l’Italia con i miei nonni, che io avevo conosciuto davvero poco, visto che erano morti tutti abbastanza giovani per malattie o per incidenti sul lavoro. Ai tempi dei miei nonni gli italiani a New York erano un gradino sotto i cani di strada. Non che per me le cose fossero state tanto diverse.
Insomma, ai miei occhi l’Italia era solo storia vecchia, un luogo conosciuto attraverso racconti di seconda mano, con toni tutt’altro che entusiastici. Ecco spiegato perché il mio atteggiamento fosse così diverso rispetto a quello di Monroe.
Era quasi giorno quando mi ritrovai con l’acqua di mare fino alla cintura e gli scarponi che sprofondavano nel fondale sabbioso. La passerella che doveva evitarci il bagno s’era ribaltata su di un lato a causa di un piccolo scoglio che emergeva dalla sabbia. Era rimasta per un po’ in bilico, ma sotto il peso dei nostri passi s’era inclinata inesorabilmente sul fianco, costringendoci ad un bagno nell’acqua gelida non ancora scaldata dal sole.
Una volta raggiunta la spiaggia mi accorsi subito che l’aria, al contrario dell’acqua, era già calda e asfissiante, come in una sauna.
Mi guardai attorno e vidi che eravamo sbarcati su di una spiaggia lunga e larga che formava un grande arco verso est e poi si stendeva verso il mare aperto. Finiva con una striscia sottile di sabbia protesa quasi a toccare un piccolo isolotto ripido e scosceso che emergeva a poche bracciate di distanza dalla terraferma.
La luminosità del sole nascente di là dalle basse colline, anche se non se ne vedevano ancora i raggi, mi giocò un brutto scherzo. E per un attimo mi parve di vedere qualcosa muoversi su quel lontano isolotto. Avrei giurato di vedere la sagoma di un uomo vestito di bianco camminare svelto sulle rocce. Ma anche se indicai immediatamente ai miei compagni lo scoglio e quello che pensavo fosse un uomo, quando gli altri si voltarono la figura in bianco era svanita. Monroe fu il primo a prendermi in giro, invitando tutti ad ignorare le mie fantasie.
“Lasciàtelo perdere, il povero Frankie Shute vive in un mondo tutto suo!” – disse sghignazzando e ruotando un indice perpendicolarmente alla tempia, per sottintendere che non avevo tutte le rotelle a posto. “Ehi, Shute, si scherza, eh! Non te la prendere!”
Un altro giovane, che non aveva l’aria di uno dalla risata facile, commentò: “Sono scappati tutti. Nessuno sano di mente si farebbe trovare sulla spiaggia, vedendo arrivare centinaia di navi da guerra. Si saranno rintanati tutti in qualche buco nell’entroterra, vedrai.”
Torna all’indice di questo racconto
2
Quando ci diedero l’ordine di lasciare la spiaggia, iniziammo ad avanzare svogliatamente tra le dune. All’inizio distanziati gli uni dagli altri, formando un’immensa ala che come un’onda si spingeva dal mare verso l’interno.
Soltanto quando riuscimmo ad individuare una strada sterrata abbastanza grande anche per i mezzi pesanti, incominciammo a serrare i ranghi e a procedere in colonna. Soldati, carri e artiglieria.
Per molte miglia, fin dove arrivava lo sguardo prima di infrangersi contro le basse colline che incorniciavano il nostro orizzonte, non si vedevano segni di civiltà. A parte la strada bianca di sabbia gessosa, il resto era campagna incolta.
Nonostante fossimo in migliaia a pestare gli scarponi e decine e decine le camionette con i motori rombanti, in realtà la sensazione era quella di un ottuso silenzio. Questo attutirsi dei suoni e l’afa asfissiante dell’aria creavano l’effetto di una pesante coperta che sembrava avvolgere ogni cosa in quella terra deserta e arida.
Tuttavia quella marcia silenziosa non durò per molto.
La strada procedeva polverosa serpeggiando tra cumuli di sabbia, rocce calcaree basse e levigate e gruppi di canne gialle. Queste ultime decoravano gli avvallamenti limacciosi che costeggiavano a destra e a sinistra il cammino.
Quando ci trovammo ad imboccare una gola più stretta, tra due tozze colline rocciose piene di crepe molto nette scintillanti di cristalli di gesso, ci piovve addosso la prima smitragliata dall’altura a est.
A quanto pare non tutti si erano ritirati nell’entroterra. Qualcuno era rimasto ad ostacolare il nostro passaggio. Qualcuno con almeno una mitragliatrice Breda calibro 8.
Evidentemente le nostre avanguardie non avevano individuato il pericolo a causa dei tanti profondi anfratti che venavano quelle rocce. I nemici dovevano essersi nascosti dentro una di quelle grotte o crepacci che si vedevano dalla strada, ancora oscuri come la notte appena passata.
A quella prima sventagliata di piombo ne seguì subito una seconda. Ma stavolta doveva provenire dall’altura che sorgeva verso ovest. Non potevamo esserne sicuri, poiché già dopo i primi colpi ci eravamo rintanati dietro il blindato più vicino, schiacciando il più possibile i nostri corpi sulla strada.
Il risultato fu che da un lato arrivavano proiettili che miravano al blindato che ci precedeva, mentra dall’altro lato i colpi erano diretti al blindato che ci seguiva. Solo di tanto in tanto, non saprei dire se per volontà dei tiratori o per rimbalzi fortuiti, qualche colpo andava a segno sul metallo del carro che ci riparava.
La polvere che si era alzata avanti e indietro, rispetto alla nostra posizione all’interno del convoglio, creò in pochi minuti due muraglie fumose e bianche che ci separarono visivamente dal resto dell’esercito.
Nonostante il chiasso infernale che adesso ci circondava, era evidente a tutti che il nemico in quel punto disponeva di un armamento irrisorio rispetto alla potenza di fuoco che ci portavamo appresso noi altri. Ma l’errore di valutazione da parte del comando, che non si aspettava che avremmo ingaggiato uno scontro così vicino alla costa, ci aveva fatti arrivare in quel punto con ancora le mitragliatrici e i cannoni smontati e del tutto non operativi.
Quando la pioggia di proiettili cominciò ad accanirsi maggiormente sul nostro blindato, fummo costretti a gettarci tutti quanti nel canale limaccioso alle nostre spalle. Frustati dalle canne ci ritrovammo all’improvviso in una fanghiglia maleodorante e caldissima, tempestata da un’infinità di insetti. Pensai che se dovevo scegliere tra le mitragliatrici e la malaria, tanto valeva tornare sulla strada a fare da bersaglio.
Non riuscivamo ancora ad individuare i punti esatti dai quali ci sparavano, nonostante il sole fosse ormai alto.
Allo stesso tempo mi venne da ridere al pensiero che il nostro convoglio era così numeroso che molti dei miei compagni dovevano ancora trovarsi in spiaggia ignari di tutto quello che stava avvenendo a miglia di distanza. Mentre noi ci trovavamo nell’occhio del ciclone.
Proprio per questo motivo non potevamo di certo restare lì a fare da bersaglio. Per cui, vedendo un fitto e basso boschetto di mandorli alle nostre spalle, cercammo riparo tra la vegetazione.
Il maggiore era con noi e ci fece notare subito che addentrandoci nella boscaglia, anche se l’artiglieria continuava a sparare, nessuno più faceva fuoco su di noi. Non potevamo tornare sulla strada e non potevamo restare fermi al riparo esile di quegli alberelli. Sarebbe bastata una sventagliata di proiettili per falciare tutto, uomini e alberi insieme. Così il maggiore ci indicò con gesti convulsi come il bosco scendeva lungo un pendio e poi in una curva risaliva sul dorso del piccolo monte alla nostre spalle. Uno dei due rialzi dai quali provenivano gli spari. Potevamo prenderli alle spalle!
L’avanzare sotto gli alberi era davvero difficoltoso, per via delle grosse zolle di terra bianca e asciutta e per le infinite secche piante spinose che ci pungevano ad ogni passo. Specie in salita la pietraia ci ostacolava con piccole ma numerose frane.
Il piano inoltre si rivelò un fiasco, perché una volta sulla cresta della montagna ci ritrovammo inaspettatamente scoperti. Anche se eravamo effettivamente finiti alle spalle di un gruppo di tre italiani con una mitragliatrice, che non si erano ancora accorti della nostra presenza. Allo stesso tempo ci ritrovammo di fronte altri soldati, italiani o tedeschi che fossero, che dall’altra cresta, al di là della strada ci videro immediatamente e ci falciarono con una pioggia di proiettili da una MG 42.
Vidi il cervello del maggiore volar via fuori dal foro che un proiettile aveva aperto attraverso il suo cranio e l’elmetto. I miei compagni caddero come tanti sacchi vuoti. Io sentivo fischiare i proiettili in ogni direzione. L’unica cosa che potei fare fu lasciarmi cadere all’indietro lungo la scarpata pietrosa che ci eravamo appena lasciati alle spalle. La stessa cosa fece Monroe subito dietro di me.
Purtroppo il nostro rotolare tra le pietre e i rovi non si arrestò prima che la ripida discesa si trasformasse in un dirupo. Cademmo nel vuoto per qualche metro, finendo in un nuovo torrente di melma putrida.
Nonostante l’impatto finale fosse stato attutito dal fango, persi ugualmente i sensi.
Torna all’indice di questo racconto
3
Quando riemersi dall’oblio era già il tramonto. Cercando di rialzarmi mi accorsi di essere tutto un dolore e pieno di tagli. Caviglie e polsi mi scricchiolarono sonoramente e non senza pena. Ma tutto sommato non avevo nulla di rotto. Avevo solo perso l’elmetto e il fucile.
Una volta in piedi fuori da quel pantano ancora caldo mi accorsi che Monroe era steso a pochi metri da me, lamentandosi.
Anche lui era coperto di tagli e in più non riusciva a muoversi per via di una spalla fuori posto. Era conciato abbastanza male.
In qualche modo riuscii a tirarlo fuori dal pantano e a rimettergli a posto la spalla. Al resto ci avrebbe pensato da sé, ripulendo e fasciando alla meno peggio i tagli più vistosi.
Di lì risalimmo a fatica sulla strada. Era deserta, eccezion fatta per alcuni rottami e per un carro mezzo sprofondato nel fango. Nessun corpo a terra.
Ci servì qualche minuto per farci coraggio e rimettere i piedi sullo sterrato biancastro. Non ci sparò nessuno. Evidentemente i nostri erano riusciti a sopraffare quel manipolo di nemici sulle due creste. Dopodiché l’esercito era avanzato.
Ma non si erano accorti della nostra assenza? Si erano almeno fermati a recuperare i corpi dei nostri compagni caduti sulla montagna? Sapevo bene che non eravamo altro che carne da cannone, tuttavia era protocollo standard fare la conta dopo uno scontro. Le uniche opzioni accettabili erano che ci avessero registrati come dispersi o molto più probabilmente come disertori.
L’unica cosa da fare era seguire le tracce lasciate dal convoglio e sperare di raggiungerlo prima della notte. Di tornare indietro non se ne parlava neanche, altrimenti avremmo tolto ogni dubbio relativo alla nostra diserzione.
Conciati come eravamo, avanzammo molto lentamente per qualche ora, di conseguenza fece buio prima di poter raggiungere il resto dell’esercito. Eravamo ancora zuppi di fango e sudore, mentre l’aria fresca della sera sommata all’idea di trovarci da soli e disarmati in territorio nemico ci raggelò il sangue.
La luce lunare ci permise di individuare un’altura che si rompeva a mo’ di piccolo teatro. Doveva trattarsi di una cava abbandonata. Ci accampammo al suo centro, di modo da avere le spalle coperte e riuscire ad avere lo stesso una buona visuale sulla bianca linea di terra che era la strada. Era ottusamente forte la speranza di vedere tornare qualcuno indietro a cercarci.
Io ero preoccupato per Monroe, che sembrava soffrire molto più di me il freddo. Lo sentivo tremare, ma di accendere un fuoco non se ne parlava o saremmo diventati bersagli troppo evidenti. Per cui non potevo né scaldarlo né controllare lo stato delle sue ferite e capire quanto sangue avesse perso.
Soltanto molte ore dopo i suoi lamenti si fecero più sottili e capì che si era addormentato.
Quella notte non ci fu mai davvero buio, la luna aveva illuminato per tutto il tempo il paesaggio che ci circondava. Eppure la semioscurità svelava forme misteriose ai miei occhi di straniero. Non c’era nulla in quello sfondo appena accennato che io riuscissi a riconoscere. A parte la strada che serpeggiava bianca appena sotto di noi, il resto era un confuso mescolìo di rocce, arbusti, alberi e, credo, grano o qualcosa di simile.
Proprio quando i raggi della luna iniziarono a cedere spazio alle prime luci del sole, in mezzo a quel grano notai un movimento anomalo, come un’onda nel mare. All’inizio pensai a qualche grosso coniglio o ad una volpe, ma quel moto era troppo prolungato per essere causato da qualcosa di piccolo come una volpe o un coniglio. Doveva esserci almeno un esercito di conigli a correre in fila per causare tutto quel trambusto di spighe. Così all’improvviso pensai al nemico.
Senza perdere mai il contatto visivo con quell’ombra che ci strisciava intorno, svegliai il mio compagno e in silenzio gli indicai quella potenziale fonte di pericolo.
Stranamente Monroe mi parve subito lucido e accolse le mie preoccupazioni senza dubitarne nemmeno per un attimo, facendole immediatamente sue.
E fu proprio una fortuna che anche lui stesse osservando in quel momento quella cosa. Nell’istante esatto in cui emerse in parte tra le spighe pallide, mostrando un dorso scintillante come un cavo d’acciaio intrecciato, simile a quelli utilizzati nei grandi cantieri a New York. Qualunque cosa fosse, era lungo diversi metri. Non avrei saputo dire esattamente quanti, non riuscendo a vederne l’inizio né la fine. La sensazione del suo peso che schiacciava la terra mi fece pensare che il diametro di quel corpo doveva essere di almeno mezzo metro.
Azzardammo immediatamente qualche passo nella direzione opposta, cercando di non produrre il minimo rumore. Ma com’era ovvio quella cosa sapeva già della nostra presenza. Tanto che non servì nessun fracasso da parte nostra per fargli cambiare lentamente rotta e reindirizzarla proprio verso di noi.
“Corri! Corri!” – urlai a Monroe.
Ci gettammò allora giù per la collina come animali braccati, inciampando ad ogni passo sul terreno accidentato. Anche per questo non mi ero fatto la minima illusione sulla riuscita della nostra fuga. Quella cosa nel grano, qualunque cosa fosse, scivolava rapida e senza intoppi su quella terra, al contrario di noi.
Eppure riuscimmo a raggiungere in pochi secondi nuovamente il livello della strada, ma dal lato sbagliato della collina. Così ci eravamo nostro malgrado ricacciati nel fango di un campo paludoso coperto di alte e fitte canne. Quel fondale limaccioso ci rallentava ulteriormente e non potevamo permettercelo. Nell’istante in cui, tra le canne, intravidi una specie di isolotto che emergeva al centro della palude, feci cenno a Monroe di raggiungerlo. Forse da quel punto avremmo potuto difenderci meglio. La luce bluastra dell’alba mostrava senza ombre un piccolo rudere di una minuscola casa, proprio sopra l’isolotto. Sarebbe bastato a nasconderci? Valeva la pena provare.
“Nascondiamoci tra quelle rovine!” – bisbigliai.
Appena messo piede sulla terra asciutta, mi resi conto che di quella costruzione era rimasto in piedi solo lo stipite di una porta e qualche lembo di parete. Le pietre che avevano composto in origine la casina, erano sparse su tutto l’isolotto, quasi come se ci fosse stata un’esplosione.
Fu proprio mentre cercavamo di raggiungere quello che restava ancora in piedi delle mura, che vidi un’ombra enorme abbattersi sibilando su Monroe. Quell’improvvisa aggressione stava avvenendo a pochi passi da me, tuttavia non riuscivo a mettere a fuoco ciò che vedevo.
I movimenti erano sincopati e la massa nera si contorceva attorno al corpo dell’uomo ad una velocità furiosa.
Ad un tratto parve quasi liberarlo dalla sua morsa, ma solo per riassalirlo un istante dopo. Monroe era incredibilmente ancora in piedi. Lo vidi barcollare all’indietro di qualche passo verso lo stipite della casa crollata quando la cosa, con un balzo in avanti, lo colpì al petto, trascinandolo con sé proprio attraverso quel varco.
Fino a quel momento, ciò che avevo visto poteva ancora essere spiegato in maniera razionale – un animale selvaggio, forse qualcosa simile ad un boa, ma dannatamente più grande. Ma quello che vidi poi, è tutta un’altra storia.
Quando mi ritrovai da solo nel bel mezzo di quella palude, sopra quel pezzo di terra emersa dal fango, a pochi passi da quei lembi di mura pietrose…beh, rimasi imbambolato e confuso per non so quanto tempo. Il mio commilitone, spinto dalla bestia, era sparito nello stesso istante nel quale aveva attraversato l’arco, seguito dall’interminabile e gigantesco corpo nero della creatura. Sparita anch’essa, man mano che oltrepassava quella soglia abbandonata.
Ma dove? Come?
Non c’era niente oltre quel fantasma di una porta, a parte l’aria del mattino e qualche pietra caduta. Non c’erano fossi, né alcunché per nascondersi alla vista. Pensai anche a qualche gioco di specchi, uno di quei complessi trucchi da illusionista. Ma avvicinandomi e toccando le pietre e il legno degli stipiti non trovai nulla, né da un lato né dall’altro.
Ero impazzito? Mi aveva morso qualche strano insetto europeo causandomi allucinazioni col suo veleno? O magari erano stati i miasmi di quella maledetta palude a scombussolarmi il cervello?
Non mi restava altro da fare se non…
Attraversai anch’io la porta vuota.
.
Torna all’indice di questo racconto
4
Non era più l’alba, non ero più sull’isolotto e davanti a me non c’erano più i ruderi di prima. Appena i miei occhi si abituarono alla scarsa luminosità delle lampade a olio e delle candele che baluginavano agli angoli della stanza, riuscii a vedere dove mi trovavo adesso.
Le pareti erano di pietra, il soffitto era molto basso. Una finestrella si apriva sulla sinistra, ma da essa non penetrava alcuna luce, come se fuori fosse notte fonda.
Anche se minuscola, la stanza nella quale mi trovavo, era ugualmente piena di vecchi mobili e suppellettili di vario genere. Ogni singolo oggetto aveva l’aria di essere molto antico, anche se ben tenuto. Nonostante la scarsa luce, mi sembrò evidente che quella casa non era abbandonata. Qualcuno ci viveva lì dentro!
Alle pareti erano appesi cesti di vimini, grandi e piccoli, e anche diverse trecce d’aglio, mazzetti di erbe aromatiche e qualche largo tegame di latta. Era tutto molto rustico, ma non c’erano né polvere né ragnatele su nessuno dei mobili. Una credenza, un tavolaccio e alcune panche basse.
Mi voltai d’istinto e vidi che nel punto dal quale dovevo essere passato io, adesso c’era una spessa porta di legno scuro con un pesante chiavistello di ferro.
Sul lato opposto si apriva un altro varco, una porticina si affacciava su una seconda stanza, anche quella illuminata scarsamente da candele.
Avvicinandomi vidi che dalla seconda stanza si poteva accedere ad un corridoio, sul quale si intravedevano altre porte, alcune aperte e alcune chiuse. Ma da nessuna di esse provenivano suoni.
Mi si fermò il cuore nel petto quando, proprio sulla soglia della seconda stanza, mi accorsi di aver calpestato qualcosa di viscido. Ma cosa?
Sollevai una delle lampade a olio e l’avvicinai al pavimento. Era sangue?
Una piccola pozza di sangue che sbavava in una larga e lunga striscia che portava diritta verso il fondo del corridoio.
Entrai allora nella seconda stanza, terrorizzato al pensiero di cosa avrei trovato.
La luce fioca svelava le pance di alcune botti. Dall’odore avrei detto vino.
C’erano anche delle sedioline di corda accatastate in un angolo, insieme ad altre cianfrusaglie di nessuna importanza per me. Quindi imboccai nuovamente lo stretto corridoio.
Le successive due porte, una a destra e una a sinistra erano chiuse e non feci il minimo tentativo di aprirle. La terza era aperta e molto cautamente ci infilai prima il braccio che reggeva la lampada e quindi la testa. Pareva vuota, ad eccezione di un piccolo letto di paglia posto in un angolo, e anche qui le piccole finestrelle che davano verso l’esterno non lasciavano entrare nessun bagliore.
Procedetti ancora a piccoli passi verso il fondo del corridoio. Man mano che avanzavo mi rendevo conto che, non solo il fondo di questo percorso era meno illuminato, ma anche le pietre delle pareti diventavano sempre più scure. Non saprei dire se si trattava di un tipo diverso di minerale o se qui la parete era coperta di qualche tipo di muffa nera.
Torna all’indice di questo racconto
5
Il corridoio, sempre più immerso nell’oscurità, proseguiva conducendo a svariate altre stanze. Eppure non dovetti esplorarlo per tutta la sua lunghezza. La scia di sangue infatti mi indicava la strada, attraversando la quinta porta. Era aperta.
La lampada qui mi mostrò la sagoma di Monroe: era seduto su di una seggiolina al centro della stanza. La traccia di sangue si trasformava in una scura pozza sotto di lui.
Aveva la testa china in avanti e il suo busto era curvo, quasi piegato sulle ginocchia. Pareva morto.
“Monroe!” – bisbigliai, quasi del tutto senza fiato – “Tutto ok?”
Non ebbi risposta, a parte un rantolo umidiccio.
Mi correggo: ricevetti risposta, ma non fu Monroe a rispondermi.
Alle mie spalle infatti sospirò una sottile voce femminile. Il tono era leggermente grattato, come quello di chi ha appena pianto. Mi volsi di scatto per trovarmi così di fronte il viso pallido di una giovane donna, incorniciato da lunghi capelli corvini che scintillavano alla luce della lampada.
Parlò ancora, ripetendo le stesse parole che non avevo colto un attimo prima e che continuavo a non capire: “Iu e lu sangu miu amma stari a suli! Vatinni! Vatinni!”
Adesso stava quasi gridando e il suo corpo era scosso da fremiti di rabbia. Era giovanissima, esile e bassa di statura ma furono i suoi occhi a convincermi quanto fosse una minaccia reale. Erano gialli, come quelli di un animale.
Un attimo dopo la donna non si trovava più di fronte a me, sulla soglia della stanza, ma si era rapidamente e silenziosamente spostata alle mie spalle. Adesso si trovava tra me e Monroe e si muoveva verso di lui con piccolissimi passi, quasi strusciando i piedi nudi sul pavimento.
“Raffieli… Raffieli, anima mia…” la udìi bisbigliare una volta raggiunto Monroe.
Soltanto in quel momento mi accorsi, alla tenue luce che baluginava in quella stanza, che nella mano destra stringeva un oggetto. Faticai a distinguerne la natura: pareva scintillare come l’acciaio, ma il colore mi parve biancastro, come un osso. Ma la sua forma e il modo in cui lei lo brandì mi tolsero ogni dubbio sulla funzione di quell’oggetto. La ragazza minuta stava per pugnalare Monroe con quella specie di grosso dente bianco e affilato!
Mi scossi dalla sensazione di sogno ad occhi aperti che mi aveva intorbidito i sensi fino a quel momento e con poche falcate fui addosso alla donna, nell’istante in cui il suo braccio armato teso verso l’alto stava per scagliarsi su Monroe.
Due cose mi stupirono all’istante: quanto la sua pelle era fredda e viscida al tatto e l’enorme forza con la quale mi scaraventò in aria. Afferrare il suo esile braccio fu per me come aggrapparmi ad un treno che ha già acquistato velocità. Lo strattone che subii bastò a farmi volare molto oltre la sedia di Monroe, quasi sul fondo della stanza.
Eppure in qualche modo ero riuscito ad evitare che il suo fendente colpisse l’uomo.
A quel punto successe una cosa che, seppure l’intera situazione fosse già molto al di là di ciò che potevo considerare normale, mi parve ancora più strana e insensata.
La donna, col viso nascosto in parte dai lunghi capelli scuri, parlò ancora una volta, ma stavolta lo fece con una voce completamente diversa e, cosa che mi lasciò stordito come l’esplosione di una granata, parlò nella nostra lingua.
“Luke, perdonami!” urlò. “Non succederà più, te lo giuro!”
Vidi la testa di Monroe, che fino a quel punto m’era parso privo di sensi, alzarsi di scatto sentendo pronunciare il proprio nome di battesimo. Ma un brivido freddo mi colse non appena, con voce stremata e terrorizzata, gli sentii dire: “Angie? Sei tu, piccola mia? Ma come diavolo…?”
Così mi accorsi che anche io conoscevo quella voce, anche se impastata dal pianto. Sembrava in tutto e per tutto la voce di Angie, la moglie di Monroe. Ma non era possibile, non era lei, non le assomigliava nemmeno. Angie era bionda e alta quasi quanto suo marito. Non era di certo lei quella piccola donna pallida che, in piedi davanti a Luke, adesso piangeva con quella voce impossibile.
“Ti prego, perdonami! No, Luke, lasciami! Il bambino… il bambino sta dormendo, si sveglierà! Te ne prego, lasciami, non lo farò più…” continuava quel demone la sua imitazione folle.
Al che, udìi sempre più forte la voce di Monroe salire d’intensità e con collera crescente urlare: “Non ti ho fatto niente, femmina, smettila di frignare! Lasciami in pace o ti faccio vedere io chi è che comanda in questa casa!”
A queste parole fece seguire il gesto di alzarsi dalla sedia, ma le forze gli mancarono e ricadde immediatamente giù come un sacco di carbone.
La donna si zittì, smise anche di singhiozzare, all’improvviso così come aveva iniziato.
Ci fu un silenzio ronzante per non so quanti secondi, o forse minuti. Tutto era immobile. La donna ritta in piedi con le braccia a penzoloni e la testa china in avanti. Monroe ferito e forse nuovamente svenuto sulla sedia di legno. Ed io a pochi passi di distanza, ancora mezzo sdraiato sul pavimento di pietra, così com’ero caduto quando quella cosa mi aveva scaraventato per aria.
Fu un urlo atroce a rompere il silenzio. Quella creatura, qualunque cosa fosse, aprendo la bocca in un modo assolutamente innaturale, cacciò fuori un lamento straziante, lunghissimo. Sia io che Monroe sussultammo sconvolti. La pelle mi si accaponò quando l’urlo si spense infine in un vibrante sibilo, mentre il viso di donna parve schiudersi in un sorriso maligno, che di umano aveva ben poco. Infatti tra le due file di piccoli denti bianchi, per un attimo, guizzò fuori una lunga e sottile lingua rossa, che quasi sfiorò il viso di Monroe.
Nello stesso istante, come scosso da una scarica elettrica di puro terrore, riuscii a scattare finalmente in piedi, trovandomi così nuovamente faccia a faccia con quella maschera di donna. Vidi i suoi occhi gialli sgranarsi di colpo e fissarmi stupiti, come se avesse dimenticato per un attimo la mia presenza in quella stanza.
Intanto percepii il respiro affannato di Monroe e ricordo che pensai “E’ ancora vivo, posso ancora portarlo via da quest’incubo!”.
Ma la creatura urlò nuovamente, facendomi indietreggiare di un passo, mentre con la mano disarmata afferrava i capelli di Luke tirandolo con forza a sé.
Con una velocità insensata la vidi voltarsi, scivolare rapidamente verso la porta, trascinandosi dietro il povero Monroe urlante di disperazione.
Così, prima che il buio del corridoio li inghiottisse entrambi, anche io mi fiondai verso la porta della stanza. Feci in tempo a vederli entrare in una delle altre stanze che si aprivano sul lato destro del corridoio. D’istinto scattai in avanti per raggiungerli, ma mi bloccai quasi immediatamente. Mentre vedevo sparire i piedi scalcianti di Monroe dentro l’uscio oscuro della terza stanza sulla destra, già vedevo sbucare il viso pallido della donna dalla quarta stanza sulla sinistra. Pareva scivolare, senza nemmeno più muovere i piedi per camminare, tanto andava svelta. Così li vidi sgusciar fuori dalla quarta stanza a sinistra, entrare nella quinta porta a destra e di nuovo comparire attraverso una porta alle mie spalle in fondo al corridoio sempre più buio.
Anche se ciò che stavo vedendo non aveva alcun senso, ugualmente cercai di raggiungerli. Ma i miei scatti in avanti e indietro erano ridicolmente inutili. Me ne resi conto solo quando la donna e Monroe apparvero dalla prima delle stanze che avevo visto imboccando quel corridoio la prima volta. Senza degnarmi di uno sguardo quel demone si scagliò verso l’uscita del corridoio e quindi della casa. Ed io, correndo con tutte le mie forze, fui subito dietro loro. Anche perché all’improvviso l’idea di rimanere bloccato in quella casa infernale da solo mi atterrì non poco.
La luce dell’alba mi accecò e quasi caddi bocconi a terra. Implorai i miei occhi di abituarsi subito alla nuova condizione, perché sentivo ancora la voce sibilante della donna e le urla angoscianti di Monroe allontanarsi rapidamente da me.
Quando fui di nuovo capace di distinguere le forme che mi circondavano, capii che mi trovavo ancora una volta sull’isolotto al centro della palude. Lo stesso sul quale poco tempo prima io e Monroe cercavamo riparo dalla creatura che ci inseguiva. Vidi subito alle mie spalle lo stesso stipite semi-crollato della porta e i ruderi subito oltre, appena visibili, coperti di sterpaglie. Tutto intorno si stendeva una zona acquitrinosa, già riscaldata in maniera insopportabile dai primi raggi di sole. Il senso di umido tepore fu la seconda cosa che mi investì, dopo la luce.
Lo smarrimento che ne seguì si interruppe nell’istante in cui vidi una enorme coda nera e scagliosa venire inghiottita dal fitto canneto. Corsi anch’io in quella direzione, guidato dalle urla di Monroe e dallo sconquasso di acqua che sentivo ancora distintamente.
Tuttavia, non appena tentai i primi passi dentro l’acqua scura della palude, mi fu chiaro che non li avrei mai più raggiunti. Le mie gambe, già provate dalla marcia del giorno prima e dagli eventi della nottata, adesso non riuscivano a contrastare la viscosità di quei fanghi densissimi.
Al contrario, potevo percepire la naturalezza con la quale la creatura scivolasse rapida sulla superficie e in mezzo alla fitta vegetazione giallastra. Io avevo percorso con immensa fatica poche iarde, che già le urla non si sentivano quasi più, tanta era la distanza percorsa da quella dannata cosa strisciante.
Li avevo persi.
Torna all’indice di questo racconto
6
Camminai per ore, ignorando il dolore bruciante emanato dalle mie gambe e l’incredibile sete che mi tagliava il respiro. Il fango sulla divisa s’era ormai seccato, ma le sanguisughe e gli insetti non mi davano pace.
Abbandonai la palude e quindi percorsi miglia e miglia di strade sterrate, bianche da bruciare gli occhi. Una volta che il sole fu alto, la temperatura dell’aria si fece simile a quella dell’inferno. Gli alberi che incontravo erano radi, senza mai formare un boschetto, una zona d’ombra che potesse darmi rifugio. Erano alberi secchi, bruciati da anni di arsura. Il solo guardarli aumentava la mia sete.
Solo a tarda sera raggiunsi le prime case e con esse il resto dell’esercito. Subito mi furono addosso degli inglesi, con le armi spianate. Dovetti sforzarmi di spiegare loro che sotto lo strato di fango, sterpaglia e insetti morti indossavo la divisa americana. Dissi il mio grado, il mio nome e quello della mia compagnia e mi scortarono dai miei superiori.
Il mio aspetto doveva essere peggio di quel che pensassi, perché il maggiore quasi non mi chiese niente. Si limitò a depennarmi dall’elenco dei disertori e mi mandò subito in infermeria. Intravidi accanto al mio nome quello di Luke Monroe, ma non dissi nulla.
Una volta ripulito e medicato – avevo il corpo pieno di spine e di tagli – mi diedero acqua e cibo e la stanchezza mi inchiodò alla brandina fino al giorno dopo.
Aprendo gli occhi mi accorsi solo allora che non mi trovavo in una tenda da campo, bensì capii che era stata adibita ad infermeria una grande sala di qualche antico palazzo nobiliare.
Il soffitto era in legno scuro con decori in foglia d’oro, le pareti erano vestite con ricche carte da parati e affreschi raffiguranti animali fiabeschi, frutti dai colori vividissimi e muse e putti e…
Feci un balzo sulla branda quando i miei occhi si posarono su di un grande, imponente quadro dalla pesante cornice intarsiata. Si trovava al centro della parete di fondo della grande sala. Trovai a malapena la forza di alzarmi e, barcollando, mi portai a pochi passi da esso.
Non riuscivo a credere a quello che stavo guardando.
Su un fondale scuro, nel quale appena si intuivano le sagome di alcuni alberi dal fogliame fittissimo e dalle ombre nerissime, era dipinta in lontananza una bassa collinetta con al centro una piccola casina di pietra. Ma il mio respiro si bloccò nel fissare il volto della figura pallida in primo piano. Si trattava di una giovane donna, vestita umilmente, scalza, immortalata nell’atto di avvicinarsi all’osservatore con passo leggero ma sicuro. Una serpe cingeva il piccolo piede nudo che sporgeva da sotto la lunga veste biancastra.
Ma non era quello il dettaglio che mi fece trasalire. Quel viso… era lo stesso pallido visino che aveva sconvolto la mia mente in quella folle notte nella palude. I suoi occhi nel dipinto non erano gialli, ma verdi e gentili e il suo sorriso non aveva nulla di innaturale. Eppure mi bastò uno sguardo per ripiombare nel terrore puro. Il dipinto era enorme, tanto che la figura della donna era pressoché a grandezza naturale e pareva guardarmi dall’alto verso il basso, con quella che mi parve compassione.
Alla fine i miei occhi, smarriti sull’ampia tela e rapiti da quella rappresentazione impossibile, corsero verso l’angolo inferiore destro del quadro. Alla ricerca di qualcosa che la mia mente invece desiderava rifuggire.
Con un incerto tratto bianco era vergata la firma dell’autore, Raffaele Rizzuto, e l’anno di creazione dell’opera… 1692.
Fine | Torna all’indice di questo racconto
oppure
