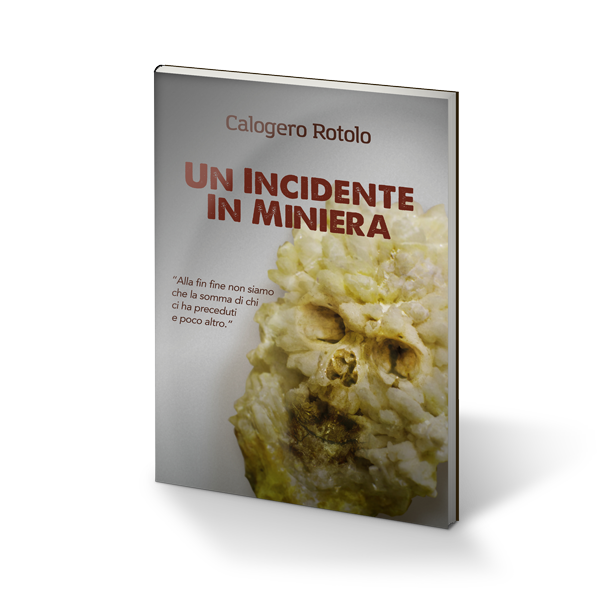
INDICE
Capitolo 1 – Capitolo 2 – Capitolo 3 – Capitolo 4 – Capitolo 5 – Capitolo 6 – Capitolo 7 – Capitolo 8 – Capitolo 9 – Capitolo 10 – Capitolo 11 – Capitolo 12 – Capitolo 13 – Capitolo 14
1
Uno… due… tre… quattro… cinque rintocchi sordi e cupi.
A seguire un sesto, ma più alto e stonato rispetto ai primi, più alto di almeno un semitono. Se non di più.
Queste note mi fecero capire che doveva essere ancora molto presto, nemmeno l’alba, e che doveva essere successo qualcosa di veramente straordinario. Perché la nonna era in fondo alle scale e ci chiamava, mentre il nonno mi teneva per mano accompagnandomi giù e poi fuori di casa.
Il nonno era molto calmo. La nonna, al contrario, era tutta un “Maria! Maria! Gesù! Gesù!”.
Ricordo che eravamo tutti e tre in strada, col cielo grigio-azzurro che precede l’alba, a guardare la facciata grigia della casa ancora in attesa di non sapevo cosa. Nonostante l’ora, l’intero paese sembrava mormorare. Anche dalle case vicine la gente era corsa fuori. Erano tutti in pigiama, anzi, essendo un paese quasi totalmente abitato da persone anziane, le donne erano in camicia da notte mentre gli uomini erano a torso nudo o al massimo con una canottiera bianca. Qualcuno, per pudore, aveva preferito tardare qualche minuto, a quella che a me pareva ancora una strana festa di quartiere, pur di abbottonarsi almeno una camicia e infilarsi le scarpe da lavoro.
Il fastidio iniziale che avevo provato quando il nonno mi aveva strappato dal letto, e che si era poi trasformato in eccitazione alla vista di tutta quella gente per strada, si tramutò in terrore pochi minuti dopo. A un certo punto sentii dire dalla vicina di casa che anche sua cognata, che abitava a chilometri di distanza dal paese, l’aveva sentito. Il terremoto.
La Sicilia, come imparai col tempo e con i successivi anni di studio, è sempre stata una terra di sconquassi geologici. Quel mio primo ricordo di un terremoto a casa dei nonni non fu l’ultima esperienza di questo genere per me. Più di una volta fummo costretti a rivivere quel primo terrore.
Per fortuna mai le case crollarono in paese. Solo qualche crepa e qualche gattone a terra, giù dagli antichi balconi del centro storico.
Eppure, questa instabilità del suolo devo ammettere che me la sono sempre portata dentro, più che come un ricordo, come una consapevolezza. Non so spiegare meglio.
Va aggiunto che, alla natura di per sé instabile di quest’isola, l’uomo ha dato un carico anche maggiore negli ultimi secoli. Lo sfruttamento del suolo da parte dell’agricoltura, una delle poche fonti di reddito conosciute dagli abitanti di queste province, e l’urbanizzazione selvaggia di quella che anno dopo anno smette di essere campagna per diventare periferia… Sono tutte concause di un dissesto idrogeologico che, innegabilmente, ha reso ancora più fragili gli equilibri di questa terra.
Se poi si pensa al sottosuolo, beh, qui per secoli o forse migliaia di anni, si è scavato per estrarre il sale, si è scavato per il gesso e si è scavato per lo zolfo. Non di rado infatti si assiste oggi all’apertura di vere e proprie voragini, ampie centinaia di metri, che senza preavviso inghiottono a brani la campagna, a causa dell’infiltrazione delle acque che erodono le gallerie abbandonate di tutte quelle vecchie miniere.
Voglio qui dare spazio a questi pensieri razionali allo scopo di individuare le forze che mi portarono un giorno a venire inghiottito dalla terra. Anche se, in cuor mio, dopo tanti anni da quel primo “incidente”, sono sempre più convinto che il mio cadere fu la risposta involontaria a una chiamata. No, non chiedetemi da chi o da cosa provenisse quella chiamata. Forse non saprò mai dirlo con certezza.
So soltanto che a questa chiamata risposi, più o meno coscientemente, tante volte nella mia vita e tante volte ancora sarò costretto a tornare sui miei passi per riprendere questo cammino, che fu deciso per me già molto tempo prima che io nascessi.
Torna all’indice di questo racconto
2
La mia passione per le escursioni in mezzo alla natura fonda le sue radici nelle passeggiate che mio nonno mi faceva fare da bambino. La campagna era per me, pallido bambino di città, un mondo di misteri e avventure. Ogni albero, ogni insetto, ogni strana roccia era l’inizio di un viaggio della fantasia. La pazienza con cui il nonno mi spiegava la vera natura di quelle fantastiche cose, che vedevo per la prima volta in vita mia, era enorme, tanto quanto la mia curiosità.
Col tempo le passeggiate divennero escursioni sempre più ardimentose, alla ricerca di tutti quei luoghi remoti delle campagne circostanti, che mio nonno aveva conosciuto da ragazzino. Antichi abbeveratoi quasi inghiottiti dalla vegetazione, rocce bucate da piccole tombe preistoriche, boschi di mandorli abbandonati e inselvatichiti. E ogni volta ritornavo a casa dalla nonna con qualche scheggia di terracotta o qualche piccolo fossile o moneta antica oppure ancora cristalli di gesso dalle fogge per me aliene.
Quando il nonno, a causa degli acciacchi dell’età che lui chiamava “camurrìe”, non potè più accompagnarmi, io ero già abbastanza grande ed esperto da incamminarmi per le vecchie trazzere siciliane a vivere mie personalissime avventure. Fu così che quelle che prima chiamavo passeggiate poi divennero per me “trekking”. E, quando prima mi bastava uno stecco di legno preso dal bordo della strada per sentirmi pronto ad ogni avventura, poi imparai a non uscire di casa senza uno zaino pieno di cibo e acqua, gli scarponi giusti, i miei moderni bastoni da camminata nordica, una torcia ricaricabile a manovella, bussola, coltellino svizzero, berretto, stuoie, teli, corde, crema solare, spray antizanzare… Ogni anno che scendevo in Sicilia aggiungevo un nuovo gadget al mio armamentario da escursionista della domenica.
Con questo spirito e con questo carico mi attardavo giornate intere tra le colline, a tratti boscose e a tratti rocciose, che costituiscono i dintorni del paesino natale dei miei genitori. Dai campi coltivati cercavo di tenermi alla larga, perché non sono mai riuscito a superare la diffidenza dei proprietari. Non tolleravo le occhiatacce e le domande sgarbate relative a chi fossi e a cosa stessi facendo a zonzo per le campagne con uno zaino quasi più grande di me.
Ma questo non è mai stato un problema, visto che la natura pietrosa e scoscesa di quelle colline non era l’ideale per le colture. Per cui grande parte di quei territori risultavano dominio mio e dei ruderi di vecchie masserie e miniere abbandonate da tempo.
Stavo visitando proprio le rovine di una vecchissima solfara abbandonata da più di mezzo secolo quando caddi.
Avevo lasciato a piedi il paese già da alcune ore, fermandomi solo una volta per raccogliere un pugno di mandorle ancora verdi in un mandorleto al bordo della strada. L’ombra scarna di quegli alberi mi aveva dato ristoro per qualche minuto, giusto il tempo di bere un sorso d’acqua e ammirare il panorama. I richiami di alcuni uccelli nascosti tra i rami e il ronzio di un esercito di insetti era l’unico suono che mi arrivava alle orecchie.
Quando arrivai alla miniera, la prima parte che mi si parò davanti già da lontano fu la ciminiera tonda, tozza e larga. Doveva essere alta non più di una decina di metri ma, rispetto al deserto di ruderi e di rovi che la circondava spiccava come un grattacielo rossastro su di una bassa città polverosa.
Avvicinandomi ad essa man mano mi venivano incontro i resti di diversi edifici adesso appena distinguibili dalle rocce naturali. Un tempo alcune di quelle costruzioni dovevano essere state degli uffici o dei magazzini, altre invece mostravano certi dettagli che mi fecero pensare a delle abitazioni private. C’erano dappertutto cocci di piatti, piastrelle dipinte o mezze giare di terracotta con ancora il manico attaccato. Sui pochi pezzi di parete ancora in piedi mi stupii nel vedere piccoli rustici caminetti e dispense di legno incassate nel gesso.
Negli anni avevo imparato a riconoscere i cocci con un valore storico da quelli semplicemente vecchi. E lì non sembrava esserci nessun reperto interessante. Deduzione che mi veniva facilitata anche dalla consapevolezza che quella parte della Sicilia è sempre stata una zona di stratificazioni storiche infinite e quindi anche di cacciatori di tesori e tombaroli che, se ci fosse mai stato un oggetto di valore da quelle parti, di certo l’avevano fatto sparire oramai da tempo. Aggiungo che alcuni tratti di inutile filo spinato mi rendevano inaccessibile gran parte di quei resti abbandonati.
Una volta ai piedi della ciminiera, vidi con chiarezza attorno a me le tante discenderie che nei secoli erano state aperte per accedere ai chissà quanti livelli della miniera. Per lo più si trattava, nel caso degli accessi più moderni, di bassi pozzi in cemento e ferro. Mentre gli ingressi più antichi erano dei veri e propri buchi nella roccia, poco più larghi di un pallone da calcio, quasi indistinguibili dal resto del paesaggio.
Guardando quelle strette conigliere scavate dagli umani, non potevo non pensare ai racconti di mio nonno, il cui padre aveva lavorato da bambino in una miniera come questa. Nonostante fossero storie di seconda mano e vecchie di più di un secolo, avevo riconosciuto nella voce di mio nonno il dolore e l’angoscia del mio bisnonno bambino e, in qualche modo, l’avevo fatta mia. Per questo non smetto mai di ricercare e visitare i resti di miniere di zolfo, ogni volta che ne ho la possibilità. E di certo in queste zone non ne mancavano di miniere abbandonate, anche se definire miniere questi buchi nella terra appena accennati è forse un errore. Chissà se con queste esplorazioni rendo omaggio al mio antenato o se invece sto pagando un debito. Alla fin fine non siamo che la somma di coloro che ci hanno preceduti e poco altro, no?
Intanto il sole s’era fatto alto. Anche se ero uscito di casa alle prime luci dell’alba, adesso doveva già essere quasi ora di pranzo. Così, pensando ai panini nel mio zaino, presi di mira un albero di fico e la sua fittissima ombra e mi ci diressi per iniziare il mio pic-nic.
Purtroppo, le cose che sappiamo sono di più delle cose che riusciamo a tenere bene in mente nei momenti che ci servono. Io, ad esempio, sapevo che quel tipo di albero è avido d’umidità e che spesso affonda le sue radici nelle spaccature della terra o nelle grotte, coprendone l’accesso come un cappello. A questa regola non fece eccezione quel fico, sotto l’ombra del quale mi gettai stupidamente senza dare ai miei occhi il tempo di abituarsi alla nuova scarsa luminosità.
Unica nota in mia difesa è che, abituato com’ero a camminare su terreni incerti, controllai con un piede il terreno sotto l’albero un istante prima di entrare del tutto in quell’ombra che ai miei occhi sembrava ancora buia come la notte. Il terreno in un primo momento mi sembrò solido e sgombro da pietre o rovi. Ma quello che non sapevo è che sotto quella crosta di terra dura, dopo poche decine di centimetri, si apriva una delle tante bocche dimenticate di quella dannata miniera.
Torna all’indice di questo racconto
3
Non gridai, né svenni.
Con inutile lucidità, per tutto il tempo della mia lunga caduta, cercai con le mani e con i piedi un appiglio per bloccare o almeno rallentare il mio scivolare obliquo. Tutto inutile, come dicevo.
La paura, il buio e i colpi che ricevevo da tutte le parti dalle rocce che cadevano insieme a me, non mi permettono di dire di quanti metri o per quanto tempo si prolungò la mia discesa. Ma una volta fermo, mi mossi molto lentamente, nell’incertezza che sotto di me ci fosse ancora altro vuoto ad aspettarmi. Sputai tantissima terra, mentre mi assicuravo con braccia e gambe quanto stabile fosse la mia posizione. In alto vedevo ancora il vago bagliore del Sole che filtrava tra i rami dell’albero, ma non riuscivo a distinguere i contorni del buco che mi aveva inghiottito e quindi non sapevo capirne la distanza.
Con uno scatto, abbandonando per un attimo la presa sicura sulla parete rocciosa alla mia sinistra, portai la mano sulla spallina destra del mio zaino. La piccola torcia elettrica non si era staccata dal suo gancio. La presi e l’accesi subito per controllare con timore cosa mi circondava in quello spazio che sentivo opprimente. E soprattutto mi interessava vedere meglio il percorso che avevo fatto cadendo per provare subito una risalita.
Nella confusione del momento neanche mi passò per la mente di controllare me stesso, se ero ferito, graffiato o se avevo ossa rotte che spuntavano dalla pelle. L’adrenalina aveva spento nel mio cervello qualsiasi segnale di dolore il mio corpo stesse provando in quel momento.
Grazie alla luce della torcia, le ombre che si crearono lungo il tunnel obliquo che mi aveva deglutito mi lasciarono vedere la sagoma irregolare di una scala. Si trattava di una di quelle folli scale coi gradini sfalsati, scavata maldestramente nella pietra. Inoltre l’erosione delle piogge, che certamente si infiltravano in quel buco da anni, aveva rovinato ulteriormente la sagoma di quei rilievi abbozzati, facendoli sparire a tratti.
Ciononostante si trattava pur sempre di una scala!
Per cui diedi una vigorosa girata alla manovella di carica della torcia, che poi strinsi tra i denti, e iniziai a risalire. Avanzavo a quattrozampe, anche se l’angolazione quasi del tutto verticale della scala mi costringeva a portare tutto il peso sui piedi. Cosa che cercai di evitare con grande sforzo, perché sentivo che quegli spuntoni di pietra che formavano la scala non avrebbero retto a troppo carico.
Avevo già risalito diversi gradini quando ci fu un secondo crollo dall’alto che mi travolse, facendomi perdere la presa e riportandomi sul fondo. La mia paura fu subito quella di essere rimasto sepolto e bloccato dalle macerie, così iniziai a scuotermi come un pazzo. Solo una volta a quattrozampe, finalmente certo di non avere arti intrappolati nella terra, mi calmai un po’. Ma solo in parte. Perché sopra di me non si vedeva adesso nemmeno il più tenue bagliore del giorno. Il buco da cui ero caduto, doveva essersi richiuso lassù in cima. In definitiva ero stato sepolto vivo.
Torna all’indice di questo racconto
4
Raccolsi la torcia che emergeva da un cumulo di terra accanto a me. Era ancora accesa. La puntai prima in alto, inutilmente. Poi le feci fare un giro tutto intorno a quello stretto tunnel. Mi resi conto che in quel punto finiva la scala dai gradini sfalsati, ma non il tunnel. Voltandomi vidi che su una delle pareti si apriva un buco nero di poco più largo di quello in cui mi trovavo al momento.
A quel punto, la mia unica speranza sarebbe stata raggiungere una delle altre discenderie – magari una di quelle più recenti – e tentare di risalire da uno dei tanti ingressi che avevo visto in superficie. Non avevo la più pallida idea del come sarei riuscito a trovare la strada giusta, sempre ammesso che ce ne fosse una. E non avevo nemmeno il coraggio di chiedere a me stesso come pensavo di risalire dalla discenderia che speravo di trovare. Avevo nel mio zaino una corda, ma sarei riuscito ad usarla per fare una scalata? Il free-climbing all’epoca non era minimamente tra le mie passioni.
Ma i ragionamenti quasi logici che sto qui riportando non si avvicinano minimamente a quel rumore bianco che mi ronzava nel cervello in quei momenti. Era il risultato della somma degli infiniti tentativi simultanei che la mia mente faceva per trovare una soluzione, intervallato solo dalle tamburellanti pulsazioni che il mio cuore terrorizzato batteva direttamente nelle tempie e dentro le orecchie.
Dovevo tentare quella via.
Feci qualche metro all’interno di questo stretto corridoio e, illuminando avanti a me con la torcia, vidi che il passaggio faceva una curva. Superata la quale ne seguì un’altra. E quindi un’altra e ancora una e così via.
Purtroppo stavo scendendo, anziché salire, com’era invece mio desiderio. Pazienza, pensai. Meglio scendere e trovare un pozzo di risalita, piuttosto che salire e non trovare un passaggio verso l’esterno. E poi, finché la strada era sgombra potevo considerarmi fortunato. Trovare una sacca d’acqua o una frana o, ancora peggio, trovarmi io a causare un altro crollo… sarebbe stata la mia fine.
Avanzavo chinato in avanti, a tratti carponi, poiché il soffitto di quel budello di pietra era stato scolpito in maniera molto approssimativa. Probabilmente perché gli attraversatori di questo girone infernale dovevano essere stati per lo più dei bambini. Innocenti che questo lavoro rendeva inevitabilmente gobbi e la cui crescita era ostacolata dall’angustia di questi passi e dal peso folle che erano costretti a portare sulle schiene martoriate e nude.
Questi e altri pensieri simili mi inondavano la mente dentro quel tunnel. Mi tornavano a galla tutte le letture che avevo fatto in passato e le mie visite ai vari piccoli musei minerari sparsi per il centro Sicilia. Anche se tante volte mi ero avvicinato ad osservare i resti di miniere come questa, mai e poi mai mi sarei potuto aspettare di trovarmici dentro, così all’improvviso e senza averlo deciso né pianificato.
Di tanto in tanto a destra o a sinistra incontravo delle piccole insenature, delle minuscole nicchie. Forse spazi utili a poggiare una delle lampade ad acetilene usate per illuminare qua e là il cammino, altrimenti del tutto tenebroso. Oppure, pensai, delle nicchie per accovacciarsi e riposare qualche istante o nascondersi per un po’. Ma nascondersi da chi?
In alcune di queste nicchie la mia torcia illuminava al passaggio piccole sculture gialle, fatte con lo zolfo sciolto lasciato sgocciolare e solidificare. Era un gioco che alcune volte avevo fatto anche io insieme al nonno. Il risultato era come di piccole torri o palazzi di minuscole città da fiaba. Le prime sculture che incontrai erano ovviamente spezzate o quasi del tutto frantumate, coperte da uno strato di polvere nerastra o macchiate di verde. Dopo tutto erano lì da almeno un secolo!
Eppure, da un certo punto in poi, quelle nicchie mi apparvero decorate di un giallo intenso, acceso come quello di un limone. E le piccole cittadelle di zolfo erano quasi del tutto integre. Evidentemente quel pò di agenti atmosferici che erano penetrati così in profondità, tanto da squassare e invecchiare le prime sculture, non erano riuscite ad andare oltre un certo punto. Lasciando in uno stato di quiete le successive nicchie che decoravano lo stretto corridoio.
O almeno questa era la spiegazione che mi davo distrattamente man mano che queste strane e dimenticate opere d’arte povera facevano mostra di sé durante la mia fuga verso il mondo esterno.
Una cosa, però, non passò inosservata ai miei confusi sensi: quelle che prima sembravano piccole grezze città, avevano adesso un livello di dettaglio sempre maggiore, man mano che procedevo. Alcune non assomigliavano più a città, ma parevano rappresentare qualcos’altro. Ma non avrei saputo dire cosa.
Giunsi in fine ad una biforcazione.
Il tunnel, dividendosi, pareva leggermente allargarsi ancora un poco. E adesso? Destra o sinistra? Quale biforcazione scendeva? Quale saliva? Rimasi immobile a lungo, passando il fascio di luce da un buco nella roccia all’altro, totalmente indeciso sul da farsi.
Soltanto dopo essere rimasto lì fermo nella semioscurità per un po’ di tempo, iniziai a sentire il silenzio opprimente, che fin lì ero riuscito ad ignorare. Il mio ansimare, dovuto alla stanchezza e alla polvere che continuavo a inalare, mi sembrava amplificato dal silenzio ovattato e privo di eco nel quale ero immerso.
Ascoltando il mio respiro espandersi ritmico tra le pareti di pietra, allo stesso tempo, lentamente, mi costrinsi ad accettare che non ero l’unico a respirare in quel buio.
Torna all’indice di questo racconto
5
Era lì, davanti ai miei occhi, appena illuminato dalla luce della torcia. Stava in piedi, eppure mi fissava dal basso verso l’alto, nonostante io fossi in ginocchio. Era curvo, all’imboccatura del tunnel di destra. La testa leggermente ruotata, come fanno i cani quando sentono un suono che non riconoscono. Mi ascoltava. Io lo guardavo ma lui non guardava me. I suoi occhi erano chiusi, parevano sigillati. Una polvere giallastra li copriva in uno spesso strato asciutto, cancellandoli a tratti. Era tutto coperto da quella terra sulfurea, non indossava altro. Era indubbiamente un bambino.
Non avevo la forza di fare o di dire nulla, tanto era il mio sconcerto nel vedere un bambino in quello stato e per di più a decine di metri sottoterra. Nel buio.
“Cu sì?” mi chiese in dialetto. La sua voce era sabbiosa come il suo aspetto, ma allo stesso tempo il tono era acuto. Era proprio la voce di un bambino.
Chi sono io? Chi sei tu!?
Lo pensai, all’apice del mio stupore, ma non lo dissi. Quello che dissi con un filo di voce fu: “Sono caduto. Voglio tornare fuori.”
“Fora?” mi fece eco, con tono interrogativo e pensieroso. Nel pronunciare questa parola lasciò la bocca aperta, mostrando i dentoni sporgenti e irregolari che lo facevano somigliare a un piccolo cavallo dagli occhi chiusi.
Dopo una lunga pausa, voltandosi di scatto e alzando una mano tozza per farmi cenno di seguirlo, sospirò un “Veni!” e si infilò nel tunnel di sinistra. In quel movimento rapido la torcia ebbe il tempo di illuminare le sue costole sporgenti e la sua spina dorsale drammaticamente deforme. Fu un attimo e subito lo persi nell’oscuro buco.
Per un attimo mi chiesi se lo avevo visto davvero o se me l’ero immaginato. Ma già lo stavo inseguendo giù per la piccola galleria. Si muoveva rapido e nervoso come un topo, solo ruotando appena, di tanto in tanto, la testa per sentire se c’ero ancora o se mi attardavo.
L’altezza del soffitto della galleria, come dicevo, era aumentata ancora un po’, così da permettermi di portare di nuovo in spalla lo zaino, che fino a poco prima avevo dovuto trasportare in mano per evitare che sbattesse a certi spuntoni di roccia che sporgevano dalle pareti pietrose.
Allo stesso tempo iniziarono a susseguirsi una sempre più numerosa sfilza di biforcazioni e imboccature per decine di altre gallerie. Non riuscivo a trovare un senso alla struttura di quel gigantesco formicaio nel quale mi trovato. Nessun riferimento sulle pareti, nessuna separazione in livelli o in aree. In definitiva la disposizione dei passaggi mi sembrava affidata al caso.
Tuttavia la mia piccola guida procedeva a passo sicuro, scegliendo in una frazione di secondo il percorso giusto da imboccare. Ma sapeva davvero la via per uscire alla luce del sole? Se era vero, allora perché si trovava in quella aggrovigliata tomba insieme a me? E per di più in quello stato pietoso!
Così com’era partito, di scatto, allo stesso modo si fermò. E io, concentrato com’ero a tenere il suo passo nervoso senza inciampare nell’oscurità e senza sbagliare imboccatura, non mi ero accorto che non ora ci trovavamo più in una galleria.
L’ambiente era qualcosa come una stanza circolare, con una volta a cupola – assurdo a dirlo – in blocchi di pietra. Era costruita, non era scavata! Avrei giurato che camminando non eravamo risaliti neanche di un metro, bensì avevamo continuato a scendere per decine e decine di metri.
Com’era possibile che così in profondità ci fosse una… stanza?!
La base circolare aveva un diametro di cinque o sei metri, a occhio e croce. E il soffitto nel punto più alto doveva raggiungere almeno i tre metri. Tutto intorno alla base si aprivano diversi tunnel simili a quello da cui provenivamo noi.
Quando tornai con la torcia ad illuminare il mio amico sotterraneo, vidi di nuovo quel gesto con la testa. Stava ascoltando. Aspettava qualcosa. Con il capo inclinato a tratti sulla spalla destra e a tratti su quella sinistra, orientava le orecchie verso tutte le gallerie intorno a noi.
Vorrei poter descrivere il terrore, il senso di disperazione, che solo la consapevolezza di essere finito in trappola può dare. Non scappai per due motivi: le mie gambe avevano perso ogni consistenza, solo in parte per la stanchezza, e poi… dove diavolo sarei potuto scappare?
Così aspettavo tremante, facendo schizzare il fascio di luce della torcia dall’una all’altra di quelle bocche oscure che molto probabilmente comunicavano direttamente con l’Inferno.
Torna all’indice di questo racconto
6
Un attimo prima di vedere, sentii.
Era come un fruscìo di foglie o di carta mossa da un vento leggero e proveniva da tutte le direzioni. Apparvero allora, quasi tutte insieme, tante piccole teste giallastre, polverose e senza occhi. Ammetto che non mi fermai nemmeno un attimo per contarli, quindi non saprei dire quanti fossero. Sento, invece, di dover dire che quello, che fino ad un momento prima era stato per me il terrore più nero, all’istante si era mutato in pena. Erano tutti bambini, erano curvi e deformi, con le testoline crespe quasi incassate nei torsi ossuti.
S’erano fermati tutti contemporaneamente, ciascuno sotto l’arco del tunnel da cui proveniva. Così che mi parve di essere finito improvvisamente nella cripta di una chiesa o in antico museo sotterraneo, dove strane statue di santi o di satiri mi osservavano immobili dalle proprie nicchie di pietra.
Durò poco questa visione, perché di lì a breve inondarono la sala circolare correndo ad abbracciare il loro pari che mi aveva guidato fin lì. Non si dissero nulla che potei comprendere, eppure le loro voci acute e sabbiose riecheggiavano sotto quella cupola. Dalle sonorità riconobbi alcune parole dialettali, tipiche del siciliano, ma anche altre dalle consonanti leggere che mi parvero spagnole e altre ancora più gutturali erano molto probabilmente appartenenti all’arabo. Ci misi un po’ a capire che ciascuno di quei bambini parlava una lingua diversa da tutti gli altri, ma che allo stesso tempo, in qualche modo impossibile da spiegare, si capivano benissimo tra loro.
Se in un primo momento parvero ignorarmi, subito dopo scatenarono la loro curiosità verso di me, avvicinandosi a piccoli passi timorosi tutti insieme. E fu un eco di “Cu sì?”, “¿Quién eres tú?”, “Qui êtes vous?” che mi giunse da quelle bocche dai denti sporchi e sporgenti. Mentre le loro mani si allungavano per sopperire a quello che i loro occhi non potevano più fare. Avevo dita ruvide che esploravano il mio volto, i miei vestiti e il mio zaino. Toccando il quale gli sentii pronunciare “…surfaru…”, che è la parola dialettale per zolfo. Evidentemente pensavano che lo zaino mi servisse per trasportare le pietre, come i “carusi” delle miniere avevano fatto per secoli in quelle gallerie. Erano loro quei “carusi”?
Quando passarono ad esplorare la torcia – cosa che non li aveva incuriositi in un primo momento, non potendone percepire la luminosità – uno di loro, sentendola surriscaldata a causa del lungo utilizzo, esclamò “Ignis!” e per me fu come un’esplosione.
Chi erano queste strane creature che vivevano cieche nella terra e che parlavano siciliano arcaico, spagnolo, arabo, francese e persino una lingua morta come il latino?!
Torna all’indice di questo racconto
7
La mia piccola guida nuda, quando la calca attorno a me si fu diradata, mi si avvicinò e, parlando in parte a me e in parte ai suoi pari, spiegò alcune cose in un dialetto che capivo solo a tratti.
Disse che io ero venuto da “fora” e che ci volevo tornare. I rumori che avevano sentito tutti poco prima venivano proprio dal crollo che mi aveva fatto cadere nella “pirrera”, la miniera. Loro erano “carusi” di quella e di altre miniere di “surfaru” collegate e anche loro, come me, erano caduti o a cadere era stata la terra sopra di loro quando si trovavano nelle gallerie più profonde. Nessuno li cercava. Nessuno aveva potuto o voluto scavare così a fondo per salvarli o per estrarre almeno i loro corpi. Non erano tutti vittime dello stesso incidente, alcuni erano lì da molto più tempo, “assà tempu!”
Come se mi leggesse nel pensiero, rispose al mio confuso silenzio dicendo che ce n’erano altri come loro, tanti di più, ma lui non sapeva contare, ammise, portandosi una mano sulla testa per schermirsi.
“Assà carusi!”
La successiva domanda che mi ronzava in testa trovò anch’essa risposta senza essere pronunciata. Quando uno di loro, che si era allontanato di qualche passo dal gruppo e che aveva piantonato per un po’ un qualche punto imprecisato nel buio, tornò con in mano alcune strane lucertole capii. Mi fu tolto ogni dubbio in pochi secondi. Il cacciatore distribuì le lucertole ai compagni vicini e, trattenutane una per sé, la spezzò in due come si fa con il pane.
Non cerco nemmeno vagamente di nascondere la nausea che mi prese nel vedere la mano sporca di terra, zolfo e sangue portare alla bocca cavallina la mezza lucertola squarciata.
Avevo avuto la mia risposta: si nutrivano di questi rettili, che riconobbi solo quando un caruso gentile che avevo accanto me ne avvicinò una al viso per farmene omaggio, dicendomi “tirasciatu”. Forse pensava che sapendo come si chiamasse, avrei accettato educatamente il boccone. Ma lo delusi, rifiutando con un “No, grazie” accompagnato da una pacca amichevole sulla sua spalla terrosa.
Per fortuna il mio rifiuto non lo impensierì affatto, perché in pochi secondi aveva già trangugiato la povera bestia.
Grazie a quel gesto e a quel nome riconobbi l’animale: erano dei gongili, piccoli rettili simili a lucertole ma con le zampe più corte e il corpo meno sagomato, come quello di una biscia.
Lui li aveva chiamati con il nome dialettale, lo stesso con cui me li aveva presentati mio nonno molti anni prima, quand’ero bambino. Letteralmente quel nome, “tirasciatu”, era dovuto alla credenza superstiziosa che questo tipo di rettile avesse l’abitudine di risalire le culle dei neonati, poggiarsi sul petto dei piccoli e, aspirandone il “sciatu”, il respiro, rubarne l’anima.
O almeno, superstizione era la definizione che fino a quel momento avevo dato a tante storie, racconti e riti privi di un qualsiasi fondamento scientifico.
Adesso, al contrario, osservando meglio i corpi spezzati di quei rettili simili a lucertole, non potevo non vedere la luminosità innaturale di quei piccoli globuli che, come chicchi di caviale, venivano sgranati dalle loro viscere e ingeriti dai carusi. Ero ormai immerso in quella follia abbastanza da chiedere a me stesso: “Quelle piccole luci sono forse le anime rubate ai neonati?”
Ma per fortuna a questa insensata domanda non rispose nessuno, né me stesso né tanto meno il caruso che aveva saputo leggermi il pensiero fino a un attimo prima e che adesso masticava concentrato la testa di un “tirasciatu”.
Una risposta affermativa, per quanto incredibile, avrebbe dato un senso – si poteva? – alla lunga vita di quei bambini dimenticati. Sempre ammesso che tutte le deduzioni che stavo arbitrariamente facendo su di essi non fossero completamente sbagliate. Non potevano avere più di dieci o dodici anni a testa, figurarsi cinquanta o cento o mille. Impossibile!
Smisi allora questa mia indagine nell’ignoto e tornai al mio vero problema: tornare alla luce del sole.
Quando fu finita quella viscida merenda – nemmeno per un attimo avevo avuto voglia di prendere uno dei miei panini e unirmi anch’io a quel pic-nic sotterraneo – e una volta finite le presentazioni e le spiegazioni, ci alzammo tutti in piedi per procedere ciascuno per la propria strada. I carusi sparirono nella stessa oscurità che li aveva partoriti pochi minuti prima. Tutti tranne la mia guida, il bambino deforme che si era imposto volontariamente la missione di ricondurmi al mondo esterno.
E, come la prima volta, mi fece quel gesto con la mano per invitarmi a seguirlo e subito imboccò uno dei tunnel più grandi. Io avevo smesso di chiedermi la qualsiasi e lo seguii senza nemmeno pensarci su per un attimo. Solo, prima di ripiombare in quel labirinto, mi premurai di girare ancora la manovella di carica della torcia, la cui luce aveva già iniziato a tremolare. Ed eccomi di nuovo a correre giù per quell’incubo di pietra.
Torna all’indice di questo racconto
8
Avevo notato come, in diversi momenti e quasi simultaneamente, quei carusi avevano arrestato per alcune frazioni di secondo tutte le loro attività – il parlare, il muoversi e persino il respirare – tendendo le orecchie al silenzio tombale che ci circondava. Anche adesso, mentre correva avanti nell’oscurità della nuova galleria che avevamo imboccato, vedevo il mio “duca” congelarsi come un fermo-immagine di tanto in tanto, per poi ripartire più svelto di prima. Cosa si fermasse ad ascoltare non riuscivo ad immaginarlo. Come avrei potuto?
Mio malgrado, di lì a poco, l’avrei scoperto.
Durante una piccola pausa che volle fare per abbeverarsi, leccando un rigagnolo limaccioso di puzzolente acqua sulfurea che filtrava da una roccia, accadde di nuovo che si fermasse ad ascoltare l’aria. Ma questa volta la reazione fu diversa e spaventosa.
Dapprima s’irrigidì come un coniglio abbagliato dai fari di un camion. E subito dopo lo sentii bisbigliare un comando per me: “Curri!”
Guardando il terrore che s’era dipinto tutto ad un tratto su quel volto senza occhi, non me lo feci ripetere due volte e imboccai assieme a lui l’ennesimo tunnel. Oramai l’altezza delle gallerie era tale da permettermi di correre in posizione completamente eretta, anche se la pavimentazione irregolare non mi permetteva una fuga agevole. Ma da cosa stavamo fuggendo?
“Cos’è?” gli chiesi con un filo di voce, che voleva imitare il suo.
“U pirriaturi! U pirriaturi!” mi rispose.
Ovviamente non capii subito, ma ripetendo tra me e me quella parola, al ritmo di quella corsa affannata, iniziai a ricordare qualcosa.
Nel dialetto di mio nonno la miniera era chiamata “pirrera” e, se non ricordavo male, il picconiere che estraeva lo zolfo era chiamato proprio “pirriaturi”. Ma che senso aveva adesso quel nome? Oltre a i carusi, anche i picconieri erano sopravvissuti nella pancia vuota di quella miniera dimenticata da Dio? C’era tutta la squadra al completo?
La corsa all’improvviso s’interruppe. Io mi fermai perché m’ero ritrovato la mano rocciosa di quel bambino piazzata al centro del petto, nel gesto comprensibilissimo di stop.
Sembrava essersi messo nuovamente in ascolto, ma sul suo viso leggevo già i segni di un pericolo scampato. Infatti, di lì a poco, iniziò a parlarmi di alcune cose importanti da sapere riguardo quel mondo sotterraneo.
Loro, i carusi, non erano gli unici abitanti della miniera. Altri si aggiravano per le gallerie di pietra. E poi, non era tutta miniera. Nel senso che i tunnel scavati dai minatori alla ricerca dello zolfo, in un certo momento di molti secoli fa, avevano incrociato altri passaggi molto più antichi, molto più grandi. Il suo discorso era una tempesta di “assà”: “Assà tempu… assà viecchi… assà granni…” Questo mi dava l’idea di qualcosa che andava molto al di là di tutto quello che conoscevo, di tutto quello che potevo immaginare.
“Chi è u pirriaturi?” gli chiesi. E lui, con pochissime espressioni facciali e ancora meno parole, mi fece capire che si trattava di uno molto cattivo – “tintu assà” – che in vita aveva soggiogato i bambini a lui affidati dalle famiglie.
Mio malgrado sull’argomento ne sapevo già qualcosa.
In un epoca non troppo remota di miseria nera, le famiglie numerose arrivavano ad accettare denaro in cambio di un figlio. Il picconiere pagava i genitori ma sarebbe poi stato il bambino a pagare il debito, con il duro lavoro in miniera. E purtroppo non solo quello.
Ancora una volta potevo ricongiungere le parole del ragazzo con le storie che avevo appreso durante le mie appassionate ricerche riguardo le solfare. Ma lì, in quel buio, con negli occhi il viso surreale di quel bambino di pietra, possibile testimone vivente di quelle storie di orrore indicibile, quello che sapevo assumeva una dimensione incredibilmente più drammatica.
Chiesi ancora una cosa, per dissipare l’ultimo grande dubbio. Il picconiere era come loro, come me, era caduto anche lui?
“No.” fu la risposta “Iddru murì.” Lui, u pirriaturi, non era cosa viva. Era morto. Ucciso in qualche modo dalla miniera. Ma non era andato via. Era rimasto lì a dannarsi. In quel posto nel quale da vivo aveva reso dannata la vita altrui.
E così, la sua malvagità era divenuta furia nella morte. Furia cieca che bramava vendetta, la quale trovava ancora facili bersagli in questi piccoli sopravvissuti, che rappresentavano agli occhi di quello spirito tormentato il motivo della “sò cunnanna”, l’eterna condanna.
Devo sottolineare che ascoltando il suo racconto non comprendevo proprio tutto, il suo linguaggio era un dialetto che riconoscevo solo in parte. Molte delle parole che usava provenivano da un gradino evolutivo della lingua siciliana che precedeva il dialetto parlato dai miei nonni. Erano termini che quasi non nascondevano la loro origine araba, spagnola, latina, greca…
Per cui, l’idea che mi feci di quella creatura che i bambini della miniera temevano era a dir poco confusa e in ogni caso mi lasciava incredulo.
Insomma, qui si parlava di fantasmi! Non ero ancora così disperato da credere ai fantasmi, quindi presi tutta la faccenda del “pirriaturi” con le pinze.
Ma all’improvviso mi accorsi di sentire molto freddo.
Torna all’indice di questo racconto
9
In pochi minuti, nonostante la corsa sfrenata che stavamo portando avanti ormai da ore, mi ritrovai a passare dal sudare per via del caldo soffocante, al tremare come una foglia per il freddo polare che inondava queste gallerie più profonde.
Il mio amico senza nome, vedendomi in difficoltà, mi concesse una pausa. Mi fece fermare in un piccolo slargo che si formava all’incrocio di cinque diverse gallerie e si allontanò un attimo in quello che mi parve un giro di perlustrazione alla ricerca di qualcosa.
Ero talmente vittima dei tremori che non cercai nemmeno di seguirlo con lo sguardo, anche perché la torcia nella mia mano faceva traballare troppo il suo fascio di luce, rendendolo quasi inutile.
Ricordai che nel mio zaino da quaranta litri di capienza – che fin qui era stato un inutile peso – avevo appallottolato la mia giacca a vento. Questa, anche se leggera e più adatta al clima estivo della superficie, mi garantì un po’ di più la possibilità di trattenere il calore del mio stesso corpo, prima di morire assiderato.
Accanto al punto in cui avevo poggiato lo zaino vidi fuoriuscire dalla parete rocciosa diverse ramificazioni di radici secche. Nemmeno mi chiesi che pianta poteva aver affondato le proprie radici così in profondità. D’istinto ne strappai un bel fascio, che ammucchiai su di una bassa pietra larga come un piatto. Tirai fuori il coltellino svizzero dalla tasca e ne estrassi l’acciarino. Tanto erano secche quelle radici da sembrare cartone, e mi sarebbe bastata una scintilla per accendere un fuocherello. Ma per fortuna, le mie mani scosse dai tremiti non riuscirono al primo tentativo a far scaturire la scintilla che bramavo. E prima che potessi sfregare una seconda volta l’acciaio del coltello contro il magnesio dell’acciarino, il ragazzo di pietra mi saltò addosso impedendomi quel gesto folle.
Appena mi fui rialzato e ripreso dalla paura che quel balzo animalesco mi aveva fatto venire, lo vidi che, battendo il dito indice sul naso e poi spostandolo a indicare l’intera miniera, mi indicava di annusare l’aria. Intuii da quel gesto che la galleria era satura di qualcosa.
Che idiota! Il grisù!
Anche questa era una nozione, riguardante le miniere, che avevo da qualche parte nel mio inutile cervello. Probabilmente sarei morto arso vivo e sepolto, tutto in una volta, se fossi riuscito a far scaturire anche solo una scintilla.
Come dicevo, fu una fortuna che accanto a me ci fosse quel piccolo esperto abitatore di miniere. Anche perché, pur prestando attenzione, mai avrei potuto percepire quei gas letali che sono tipicamente inodore. Ma evidentemente, se io non potevo, non significa per forza che anche lui non potesse.
L’unica cosa che potei fare, quindi, fu battermi una mano sulla fronte con tutta la forza che mi restava, insultare me stesso e ringraziare lui ripetutamente, lasciandogli intendere che avevo capito e che non ci avrei riprovato.
Non restò altro da fare se non riprendere la marcia. Così guardai distrattamente l’orologio digitale che avevo al polso: erano già le sette di sera. Fuori doveva esserci ancora luce solare, ma io non potevo sapere quanto ancora lontano dal “fuori” mi trovassi in quel momento.
Quando riportai la mia attenzione all’ambiente oscuro che mi circondava, notai, ancora una volta con stupore, che oramai le gallerie che percorrevamo erano più larghe e più alte delle precedenti, tanto da diventare ampi corridoi. Alcune di queste correvano rettilinee per centinaia di metri e con la fioca luce della torcia non ne vedevo la fine. Altre sfociavano in certi slarghi che parevano veri e propri saloni. Era evidente che le mani e le menti che avevano scavato questi passaggi non appartenevano alla categoria dei poveri zolfatai. Qui c’era voluta dell’ingegneria più raffinata per poter ricavare questi enormi spazi sotterranei senza nemmeno l’ombra di un crollo o di un’infiltrazione qua e là.
Fu proprio in una di queste enormi e anomale cavità della terra che avvenne l’ennesimo incredibile incontro di quel folle giorno.
Quel poco di calore corporeo, che ero riuscito a recuperare riprendendo la nostra corsa e grazie alla giacca a vento, mi abbandonò in un colpo solo quando la luce trabballante della torcia mi rimandò indietro un bagliore diverso da quello della pietra. In quel buio fu come puntare un fascio di luce verso uno specchio e, di ritorno, rimanere abbagliato.
C’era qualcosa di bianco e, in qualche strano modo, luminescente che ci veniva incontro, attraversando placidamente quella grande piatta superficie di pietra mal levigata. E l’unica cosa che mi trattenne dal gridare e darmela a gambe fu la calma con cui stava reagendo la mia guida. Tanto attento ai suoni del sottosuolo e preoccupato dal pirriaturi e, al contrario, adesso mi pareva sereno e a tratti contento di quest’incontro. Tanto che accelerò il passo verso quella baluginante presenza, ancora una volta facendomi cenno di seguirlo.
Non appena fummo a pochi metri di distanza da quell’essere, ne potei distinguere le fattezze più che familiari. Era, difficile a credersi, un asino. Un asino albino, per la precisione. Potevo distinguerne il colore del manto, anche se mal celato dallo stesso strato di polveri che ricopriva il mio amico bambino. Ma per quanto familiare fosse la forma di quell’animale, rimanevano a turbarmi il suo colore candido e quella dubbia luminescenza che spandeva da tutto il suo corpo.
In più, proprio come i carusi, anche i suoi occhi erano sigillati dalla terra.
Era un asino, sotterraneo, albino, luminoso e cieco. Facendo a me stesso questo resoconto a mente, decisi che non avrei nemmeno provato a trovare una spiegazione a quello che vedevo. Il ragazzo non esitò un attimo e, non appena gli fu accanto, lanciò le sue braccia nude al collo dell’animale in un caloroso abbraccio e – cosa che oramai non mi parve affatto strana – iniziò a parlargli fitto fitto nell’orecchio. La sua voce era un bisbiglio e per di più quel poco che riuscii a cogliere doveva appartenere ad un dialetto molto più arcaico di quello che gli avevo sentito pronunciare fino a quel momento. Dal tono e dal ritmo mi parve che si trattasse di un resoconto delle ultime novità fatto ad un amico che non si vedeva da tempo.
Quando quel privato fiume di parole s’interruppe, anche l’abbraccio si sciolse lentamente e mi parve anche controvoglia. La scena, per quanto surreale, non mancò di causarmi un po’ di tristezza. Solo in quel momento, quando i due corpi polverosi si furono distaccati, vidi le due grandi ceste di vimini che l’asino portava legate sui fianchi ossuti. Erano enormi e piene oltre l’orlo di grosse rocce calcaree, screziate del giallo tipico dei cristalli di zolfo.
Per un attimo i due, il bambino e quell’anomala bestia, rimasero a fissarsi negli occhi per poi partire simultaneamente per direzioni opposte. Fu in quel momento che l’asino, proseguendo sul suo percorso iniziale, mi passò accanto ignorandomi, quasi come se io non fossi altro che una di quelle tante rocce che costituivano l’ambiente circostante. Nulla di più.
Prima di rimettermi anch’io in cammino, rimasi qualche lungo secondo a seguire con la torcia l’asino e il suo lento scomparire nella tenebra insieme a chissà quale mistero.
Torna all’indice di questo racconto
10
Il caruso si mostrava adesso molto più concentrato sul cammino e molto meno su di me. Ormai lo vedevo voltarsi a cercare il suono dei miei passi molto più raramente. Nemmeno ebbe voglia di darmi ulteriori spiegazioni riguardo le strane cose che incontravamo, come invece aveva fatto spontaneamente fino a poco prima. Per cui molte bizzarre scene mi trovai ad illuminare con la mia torcia: alcune antiche decorazioni scolpite nella roccia a mo’ di bassorilievo e, qua e là, diverse grandi casse di legno con sopra marchi che dovevano essere militari. Ma su nessuna di queste fugaci visioni interrogai il ragazzo. La mia curiosità mi aveva abbandonato sempre più col passare delle ore e con quel continuo allontanarmi dal cielo e dall’aria aperta che oramai andava avanti da una decina di ore.
Avevamo lasciato alle nostre spalle quel silenzioso animale albino già da un bel po’ e ci trovavamo adesso, dopo aver corso lungo infinite ampie gallerie, inseguiti solo dall’eco dei nostri stessi passi – in realtà solo dei miei, il ragazzo quasi non produceva rumore muovendosi scalzo sulla pietra -, ad attraversare un passaggio leggermente più stretto.
In questo punto lo spazio era diviso in due da una fila di colonne squadrate, distanziate l’una dall’altra di pochi metri. Evidentemente in qui i folli architetti, che avevano ideato questo labirinto sommerso, avevano valutato che il soffitto poteva rivelarsi meno stabile rispetto ai precedenti tunnel e quindi avevano inserito quell’anomalo elemento architettonico ad assicurarne la tenuta.
A dar loro ragione riguardo questa preoccupazione era proprio la presenza di enormi massi sparsi qua e là sul percorso e delle ombre cave che indicavano sulle pareti e sulla volta i punti dai quali si erano venuti a staccare quei monoliti.
Proprio a causa di questi ingombranti ostacoli fummo costretti ad usare quel colonnato centrale come fossero i birilli di una interminabile chicane, scartando una volta verso destra e una volta verso sinistra. Per cui il fascio della mia torcia e quindi anche la mia vista venivano ostacolati ad ogni svolta da questi angoli ciechi.
Mi ritrovai così ad aggirare l’ennesimo ostacolo, portandomi dalla parte sinistra del tunnel alla sua parte destra. Ma, una volta che il fascio di luce ebbe svelato il percorso al di là del colonnato, la scena muta che mi si presentò mi fece letteralmente impazzire.
Il bambino che sempre mi precedeva di qualche passo e che era appena sparito dietro la sagoma di una delle colonne, adesso che era tornato nel mio campo visivo si trovava all’improvviso sollevato a mezz’aria. Lo vidi scalciare e dimenarsi come un pesce appena pescato, mentre il suo collo era stretto da quella che sul momento mi parve una mano, ma che di una mano aveva solo la forma. Le sue dimensioni infatti erano inumane! Grosse dita angolose si stringevano a pugno inglobando il collo e gran parte della testa di quel povero caruso.
Una volta decodificata alla meno peggio quella insensata scena che mi si era parata davanti senza preavviso, l’istinto fu di spostare la torcia per svelare dapprima il braccio mostruoso cui era attaccata quella mano che pareva un macigno. E poi, con sempre più terrore, illuminare il torso e la testa di quel ciclopico silenzioso aggressore.
Non c’erano dubbi che quella immane cosa che mi si parava davanti non era un uomo, eppure in un certo qual modo ricordava una figura umana, anche se quasi del tutto snaturata. Infatti, nonostante mi fossi oramai abituato alla vista delle deformità ossee dei bambini che avevo incontrato lì sotto, contemplare anche solo per un istante questa nuova distorsione dell’essere uomano mi causò uno sconcerto e un disgusto tali che non riuscii ad emettere nemmeno un grido.
Il suo corpo si presentava viscido sotto il fascio della torcia, tanto da guizzare in piccoli lampi ad ogni movimento delle membra che la luce colpiva. Non era coperto dallo stesso strato di polveri raggrumate che avevo visto sui carusi e sull’asino.
Per dimensioni non era di molto inferiore alla gigantesca ombra che proiettava sulle pareti e sul soffitto della galleria. Il busto era la parte più deforme, perché era allungato e ritorto e raggiungeva quasi terra. Non lo descrivo come una serpe solo perché non strisciava col ventre a terra, bensì si reggeva su diverse coppie di tozze gambe. No, non zampe, erano proprio gambe umane, le gambe di un nano se confrontate con il resto. Ma erano molte più di due, tante che non riuscii nemmeno a intravedere la fine di quell’orrore contorto che si dilungava oltre la zona illuminata dalla mia torcia.
Mentre con il braccio sinistro tratteneva il capo del ragazzo, con l’evidente desiderio di stritolarlo, con l’altro braccio mi parve in un primo momento impugnare una enorme clava di qualche tipo. Ma la realtà fu molto più rivoltante e terribile.
Il suo viscido braccio destro era come scarnificato dalla metà dell’avambraccio in giù. E quella che m’era parsa un’arma nelle sue mani, compresi poi essere le ossa deformi del suo stesso arto. Era come se radio e ulna si fossero fuse in un unico orrore osseo, che mi ricordò in un flash il titanico femore di un dinosauro. Molto oltre l’orrore indicibile, fu la paura a primeggiare in fine sulle tante sconvolgenti emozioni che mi attanagliarono in quel frangente.
Essa arrivò come un’esplosione nel vedere come quell’arto scarnificato terminasse con un’altra spaventosa deformità ossea che si allungava appuntita in perpendicolare al pavimento, sporgendo sopra e sotto il braccio di quella creatura infernale.
Di certo influenzato dai racconti che avevo sentito poche ore prima, avrei giurato che quell’essere al posto della mano aveva… un contorto piccone.
La scena, che lo shock mi aveva costretto ad osservare come in un fermo immagine, riprese il suo caotico ritmo nell’istante in cui puntai la torcia sul viso del mostro. Così come il resto del corpo, anche i suoi occhi erano liberi da quei sigilli di polvere che avevo creduto comuni a tutti gli esseri di quelle profondità. E fu proprio questo dettaglio a fare la differenza.
Il lampo di luce, che investì il volto deturpato e rabbioso del pirriaturi, dovette parere più luminoso del sole a quella creatura sotterranea. L’effetto abbagliante che ebbe su di lui la mia flebile torcia causò in quella enorme figura un tale sconquasso improvviso che mollò la presa che aveva sul caruso. Questi piombò a terra con violenza, ma ebbe subito la prontezza di rotolare via da quella viscida montagna semovente.
Mentre il mostro portava la mano sinistra a proteggersi gli occhi dalla luce e roteava l’aguzzo braccio destro colpendo solo l’aria, notai il panno lercio che aveva avvolto malamente sul capo. Pareva quasi un turbante, ma non ne aveva affatto la dignità.
Abbandonando infine quel mio stato di sconvolto osservatore, accettai con sollievo il suggerimento di correre che il mio amico, ripresosi dall’aggressione, mi trasmise con una pacca sulla spalla e con il suo grido roco: “Curri!”
Dopo che superammo alcune colonne, scartando di qua e di là all’occorrenza, il ragazzino si piazzò al centro del passo e si lasciò superare da me. Vedendo l’anomalia mi arrestai anch’io e puntai la torcia di nuovo su di lui. Mentre sentivo il verso sibilante e furioso del mostro avvicinarsi inesorabilmente, vidi quel minuscolo deformato bambino chinarsi a sollevare uno dei macigni che ingombravano il passo. Spinse quel monolite, infinitamente più grande di lui, ben oltre la sua testa e lo scagliò con decisione alla base della colonna che avevamo appena superata.
Il crollo che ne seguì fu uno dei rumori più assordanti che abbia mai sentito in vita mia. Un vero e proprio cataclisma si abbattè su quell’antica galleria. Nel polverone e nell’ondata di schegge e polveri che mi investì, intravidi la sagoma giallastra del mio amico che balzava via un’attimo prima di essere travolto anche lui dalle macerie.
Torna all’indice di questo racconto
11
La polvere si posò sul fondo della galleria molto prima che terminasse l’eco che lo sconquasso sotterraneo aveva lanciato verso i più remoti angoli di quel labirinto.
Io mi trovai accucciato in una nicchia nella parete, non dissimile da quelle che avevo incontrato nei tunnel più vicini alla superficie. Tenevo lo sguardo fisso sulla minuta figura del bambino vestito di terra, della cui forza sovrumana ero da poco stato incredulo testimone.
Per quanto mi sforzassi non riuscivo ad associare a quelle scheletriche e tozze braccia e gambe nemmeno la metà della potenza necessaria a sollevare e scagliare uno di quei macigni calcarei che ora ci circondavano come gigantesche lapidi di un cimitero per ciclopi.
“Amunì!” mi disse per scuotermi dal mio immobilismo e poi aggiunse “Iddru passa!”
Con queste poche parole e con i gesti delle mani riuscì a comunicarmi che dovevamo ancora scappare, che il pericolo non era finito e che quella cosa di là dalla frana avrebbe presto trovato un’altra via per raggiungerci.
Mi rimisi subito in piedi, è vero, ma la spossatezza dovuta alla fatica fisica e mentale di quella lunghissima folle giornata mi faceva avanzare come uno zombie. Sentivo che la speranza di ritrovare la via del cielo si era affievolita tanto nel mio cuore da sembrarmi ormai solo una fantasia.
Ero tanto preso dallo sconforto che con tono diffidente gli chiesi: “Dove stiamo andando?”
“A la casa” rispose asciutto.
E io con titubanza incalzai: “Quale casa?”
“La casa di petra.”
Avevo già capito dal tono con il quale aveva pronunciato la parola “casa” che non si trattava affatto di casa mia o di casa sua o di nessuna casa intesa come luogo di appartenenza cui fare ritorno.
Eppure, la devozione che gli leggevo in faccia e il timore reverenziale che ne seguiva mi portarono a credere che quel luogo verso il quale eravamo diretti, pur non essendo la casa di nessuno, in qualche modo doveva essere un luogo sicuro, all’interno del quale trovare riparo dall’incubo che ci inseguiva.
Così decisi, ancora una volta, di affidarmi a quel piccolo enigmatico essere senza nome.
Percorremmo a passo svelto la lunga galleria divisa da colonne, fermandoci ogni pochi passi ad ascoltare impercettibili echi che partivano da chissà dove.
Al termine di quella galleria un passaggio conico, che si allargava a dismisura come una conchiglia sulle nostre teste e ai nostri fianchi, ci introdusse ad una cavità nella terra la cui immensità percepii con l’udito e con la pelle del mio corpo, più che con la vista.
L’eco dei nostri passi e dei nostri respiri adesso sembrava non avere soluzione di continuità. Ogni passo andava a sommare il proprio suono ad un riverbero incessante che si dilatava e cresceva man mano che avanzavamo. Con quel frastuono ci avrebbe sentito anche il Diavolo in persona. A tratti sentii la necessità di portare le mani a proteggere le orecchie.
Varcando la soglia di quella oscura vastità, come dicevo, tutto il mio corpo mi trasmise la sensazione del vuoto incalcolabile nel quale mi stavo stoltamente immergendo. All’improvviso ero ridotto a poco più che niente, alla stregua di una particella di pulviscolo atmosferico smarrita in un ancestrale teatro, percettibilmente prossimo agli inferi.
Nemmeno per un secondo pensai che potesse trattarsi di una caverna naturale. Non era il prodotto di qualche cataclisma preistorico, né era frutto di un processo di erosione carsica lungo milioni di anni. Troppi erano gli indizi che potevo scorgere anche solo alla luce irrisoria della torcia.
Per cominciare, il pavimento era levigato quasi alla perfezione e qua e là incontravamo delle concavità strette e lunghe. Capii in breve che si trattava del limite tra l’uno e l’altro dei megalitici blocchi squadrati che costituivano il fondale scuro di quel mondo.
Già non potevo vedere né la volta, né le pareti, tanto si ergevano adesso in quell’abisso totale di oscurità che la mia luce artificiale scalfiva appena.
Avanzavamo rapidi verso l’ignoto. La mia guida caracollava oramai al limite delle sue forze, ma senza esitare nemmeno un secondo. Pareva sapere con esattezza la posizione della nostra meta in mezzo a quell’immenso vuoto privo di ogni riferimento possibile.
Ed era proprio così.
Infatti, dopo quelli che per me furono interminabili minuti di marcia cieca, il cono di luce della torcia andò a scoprire qualcosa di impensabile fuori dal nero pece.
All’inizio mi sembrò una parete o un muro di cinta. Una struttura di pietra che si ergeva verticale per più di due metri e che scorreva a destra e a sinistra, diritta fino a sparire dalla mia vista. Poi notai che al di sopra di quell’ostacolo, sfalsato indietro di alcuni metri, si ergeva un muro in tutto e per tutto identico a quello che avevamo davanti. E, facendo qualche passo indietro, intravidi sopra al secondo un terzo muro. Parevano, nel complesso, come i primi tre gradini d’una scala mostruosamente grande.
Torna all’indice di questo racconto
12
Il caruso, soffiandomi in faccia una parola di incoraggiamento che non afferrai perché totalmente smarrito di fronte alle dimensioni oscene di quel mondo, iniziò la scalata. Approfittando delle profonde feritoie che si creavano tra i grandi blocchi che costituivano l’alzata di quel primo gradino, si appendeva con mani e piedi nudi, raggiungendo in poche mosse la pedata – se così si poteva definire la parte superiore di quello scalone.
Non ebbi idee migliori e lo imitai.
Ovviamente rischiai in più punti di scivolare e rompermi finalmente la testa, come forse ero destinato a fare in quella prima caduta oramai quasi del tutto dimenticata. La sensazione di stare vedendo infatti qualcosa di proibito, che non era pensata per occhio umano, mi pervadeva già da tempo.
Quando fummo sul terzo scalone, osai guardare in alto e, oltre il quarto scalone vidi ergersi le basi di due spaventose colonne. Tanto alte che il gesto naturale di seguirne con lo sguardo la sagoma nel senso dell’altezza mi procurò una vertigine.
Dalla base, ampia circa una decina di metri, e dalle scanalature che ne incidevano tutto il fusto fin dove giungeva il mio sguardo, mi parvero incredibilmente simili alle colonne di certi templi della Magna Grecia. Proprio come quelli che tante volte avevo ammirato nella famosa Valle dei Templi, appena fuori la città di Agrigento, proprio qui in Sicilia.
Sempre che fossi ancora in Sicilia.
Completando la scalata, il panorama cambiò e potei intravedere altre decine di quelle titaniche colonne. Si ergevano a destra e a sinistra, parallele alla scalinata, e pure in avanti, una dietro l’altra a distanza di diversi metri.
Potevo solo intuire la natura del luogo alla soglia del quale mi ero arrisicato ad arrivare. Anche se non lo vedevo, a quel punto diedi per scontato che sopra di me, molte decine di metri più in alto, doveva esserci il tetto del più grande tempio che il mondo abbia mai visto.
Smarrito com’ero, sia fisicamente in quei luoghi sconosciuti e sia mentalmente di fronte a tanto mistero e tanta grandezza, non mi accorsi del cambio avvenuto nel mio compagno di viaggio. Il ragazzo era stato messo in allerta da alcuni echi indecifrabili e aveva iniziato a ruotare la testa in tutte le direzioni con scatti nervosi.
Me ne accorsi troppo tardi ed ebbi solo il tempo di chiedermi: se aveva davvero sentito avvicinarsi qualcosa, perché non stavamo di nuovo scappando? Perché si era limitato a mettersi in guardia, anziché darmi ancora una volta l’ordine di correre? S’era follemente deciso a scontrarsi con quella creatura infernale?
Anche se avevo visto un accenno della forza sovrumana di questo bambino, quando aveva scagliato quel macigno nella galleria delle colonne, valutai del tutto impari uno scontro frontale e con scarsissime possibilità di vittoria contro quel demone picconiere.
Ma, come dicevo, era già troppo tardi quando mi voltai ad osservare il bizzarro comportamento e il fare atterrito di quell’anima antica dimenticata da Dio in un giovane piccolo corpo martoriato oltre l’immaginabile.
L’urlo sibilante che si accese come un’esplosione sulle nostre teste anticipò di una frazione di secondo la massa contorta e viscida che ci piovve addosso da un punto imprecisato dell’oscurità.
Quello che la torcia mi presentò fu il dorso spigoloso e deforme del pirriaturi. Ma già un instante dopo vedevo la sua cassa toracica e il volto furioso sormontato dal turbante di stracci luridi. Infatti quel mostro, nel balzo che aveva effettuato dal fondo della scala, era atterrato esattamente tra me e il caruso, separandoci. Come conseguenza parve non sapere decidere verso chi scatenare per primo la propria ira senza fine. S’era incantato in un balletto rotatorio che portava la sua attenzione un momento sul bambino e quello dopo su di me.
Il raggio luminoso che gli puntavo sul volto non lo turbò come la prima volta, eppure potevo leggere un’esitazione nelle sue mosse.
Ciononostante, alla fine, si decise per assaltare me per primo.
Con un secondo balzo mi fu innanzi e solo arretrando rapidamente riuscii a scansare il colpo che sferrò contro di me con il suo braccio armato, fatto d’osso scarnificato e appuntito.
L’effetto che ottenne fu che, proprio come un piccone, il suo braccio si conficcò nella pietra, incastrandosi per un attimo. Questo piccolo intoppo fu per me occasione per allontanarmi appena in tempo, giusto poco prima che dalla sommità oscura di quel ciclopico colonnato precipitasse sopra quella creatura una violenta frana di enormi macigni.
Non ebbi però il tempo di allietarmi per quella morte scampata, perché subito pensai con terrore che quel crollo doveva essere stato causato dal terribile colpo che il mostro aveva scagliato contro la base del tempio. Ciò significava con molta probabilità che si era avviato un qualche tipo di instabilità nella struttura stessa di quel gigantesco edificio, se non addirittura nella immane volta di pietra che lo sovrastava.
Era davvero la fine, stavamo per essere sepolti vivi.
Lanciai così un’occhiata spaventata al caruso, che scorgevo appena, al di là delle macerie sotto le quali vedevo ancora agitarsi il nostro inseguitore. “Questo maledetto non è morto!” pensai con stupore, ma solo per schernirmi un attimo dopo ricordando a me stesso: “Lui è già morto…”
Per cui, quando vidi scuotersi le rocce che componevano la frana, credetti che il pirriaturi stesse per liberarsi. Ma mi sbagliavo… oh Dio, quanto mi sbagliavo!
Nel moto anomalo di quei macigni, infatti, vidi subito i chiari segni di una volontà propria.
Contro ogni aspettativa di gravità, vidi quegli enormi blocchi impilarsi fluidamente gli uni sugli altri e fu proprio come vedere… un immenso uomo di pietra alzarsi da terra, prima sui ginocchi e quindi in posizione eretta.
Ero caduto di schiena quando il demone era stato travolto dalla frana. E adesso mi trovato ancora spalmato a terra, riuscendo ad alzare appena il busto per contemplare quello scenario impossibile. La torcia m’era caduta di mano e, solo per puro caso, la violenta rotazione con la quale aveva concluso la sua caduta s’era arrestata in modo da illuminare proprio quell’ennesima irreale visione.
Quando il titano di pietra si fu ricomposto del tutto, stringendo in una morsa fatale il pirriaturi tra un braccio e il petto roccioso, ebbi un altro lampo di memoria.
Pur non vedendone per intero la figura per via dell’oscurità nella quale immergeva le spalle e la testa, quella nuova creatura del mondo sotterraneo mi ricordò un’antica statua di arenaria che avevo ammirato da bambino.
Era molto simile, anche se smisuratamente più grande, ad un Telamone, una di quelle giganti statue di pietra che reggevano le colonne o l’architrave di alcuni tra i più grandi templi dell’antichità.
Ebbi giusto il tempo di rialzarmi, afferrare la torcia e poi vederlo sparire inghiottito dalla notte eterna che si apriva insondabile tra le grandi colonne, portando con sé il suo viscido e urlante prigioniero.
Sento che la mia mente non è tutt’ora in grado di figurarsi fino in fondo la smisuratezza di questo scontro tra titani in uno scenario ancor più ciclopico.
Torna all’indice di questo racconto
13
Eravamo rimasti noi due da soli, il caruso ed io, impietriti dalle eco inumane che provenivano dal cuore del tempio e che man mano si allontanavano affievolendosi fino a sparire del tutto.
Quando molto dopo il silenzio fu ristabilito in quell’antro d’oscurità, io e il mio compagno ci guardammo senza dire nulla. Anche se è più corretto dire che io guardai il suo volto esausto e lui mi ascoltò ansimare ancora in preda all’adrenalina.
Capivo adesso che la “casa di petra” che aveva nominato dopo il primo crollo era proprio quel tempio dall’origine sconosciuta con il suo custode sovrannaturale. Forse – e dico forse perché non ebbi poi il coraggio di chiedergli conferma – era stato proprio questo il suo piano per sbarazzarsi del nostro inseguitore una volta per tutte. In tal caso, questo piccolo essere s’era rivelato più scaltro di quello che il suo aspetto minuto e sfigurato potevano lasciare intendere.
Solo quando ci fummo almeno in parte ripresi dallo shock di quello scontro colossale, lui mi fece ancora una volta cenno di seguirlo. Ma stavolta, lo potrei giurare, stava sorridendo e i nostri passi furono più lenti di prima.
Seguimmo per un po’ il colonnato verso destra fino a quando non trovammo un punto dove gli scaloni erano molto deteriorati, proprio come succede a certe vecchie scale di marmo quando vengono calpestate per secoli sempre negli stessi punti. Nemmeno mi chiesi quali piedi avevano salito e sceso quella scala.
In quel punto i gradini erano tanto erosi e smussati da dimezzare la propria altezza. Questo ci permise di scendere agevolmente di nuovo verso la base.
Proseguimmo ancora lungo il primo gradino, ma non per molto. Infatti di lì a breve incontrammo una parete rocciosa sulla quale quasi si appoggiava il fianco del tempio.
Proprio là, dove la linea di base dei gradoni incrociava la roccia, si apriva un varco. Così ci infilammo in questa ennesima galleria. Fu con un accenno di sollievo che reagii nell’accorgermi che stavolta il pavimento risaliva lentamente verso l’alto.
Da quel remoto mattino nel quale ero caduto giù dalla superficie, fino a quel momento, era la prima volta in assoluto che percorrevo una strada in salita. Un barlume di speranza si riaccese nel mio cuore.
Camminammo così per altre ore, non saprei dire quante, visto che avevo rinunciato da un bel po’ a guardare l’orologio. Incontrammo diverse biforcazioni che, come al solito, la mia guida seppe superare senza esitazione, imboccando alle volte il tunnel di destra, altre volte quello di sinistra.
Ricaricai la torcia più d’una volta durante la risalita, ma l’unica cosa che mi premuravo di illuminare erano alternativamente i miei passi e la schiena curva di chi mi mostrava la strada.
Per cui non so minimamente descrivere gli ambienti che attraversammo e i dettagli misteriosi che intravedevo al loro interno. Avevo fatto già troppe scoperte per una sola giornata.
L’ultima galleria per la quale mi condusse aveva il pavimento scavato in un accenno di scalinata molto grezza. Nulla a che vedere con i blocchi ciclopici perfettamente squadrati che avevamo calpestato nelle profondità. Questa era – potevo riconoscere i segni degli attrezzi di scavo – opera degli uomini.
In cima a questa grezza scala, dove le pareti s’erano fatte più vicine e il soffitto più basso vidi una struttura in metallo. Nonostante la ruggine rossastra l’avesse ricoperta quasi completamente, lo stesso la luce della torcia mi ritornò sotto forma di pallidi riflessi metallescenti.
Sembrava un montacarichi o un vecchissimo ascensore come quelli dei grandi cantieri edili. La struttura era composta da quattro possenti colonne di ferro, che risalivano dritte lungo un oscuro tunnel verticale, e da alcune costole di metallo più leggero che costituivano una specie di cabina poggiata su di una piattaforma quadrata, anch’essa di metallo arrugginito.
Dato che non riuscivo ancora a credere ai miei occhi, corsi a toccarla e a sentire il freddo artificiale del metallo. Poggiai titubante un piede sulla pedana per valutarne la solidità.
Se si trattava di un ascensore costruito per salire e discendere lungo quel buco nella terra, forse potevo utilizzarlo anch’io per risalire i livelli della miniera e avvicinarmi un po’ di più alla superficie!
Ma il mio entusiamo incontrò una battuta d’arresto quando, perlustrando i contorni della gabbia metallica, mi resi conto che non c’era al suo interno una leva o un argano, né tanto meno un sistema elettrico o un qualche motore a benzina. Nulla. Si trattava di una semplice scatola di latta sospesa ad una spessa fune metallica intrecciata.
L’altro capo della fune, che molto probabilmente saliva fino ad una carrucola appesa in cima al pozzo di risalita e poi riscendeva in basso, era arrotolata di qualche giro attorno ad un argano a manovella situato appena fuori dalla cabina.
Mi sentivo sconfitto. Sarebbe stato impossibile per noi salire sull’ascensore e manovrare per portarlo lassù in cima. Per di più la galleria che avevamo percorso era un vicolo cieco, perché finiva lì dove iniziava la struttura in metallo.
Ma mentre mi accasciavo sul pianale arrugginito per prendere fiato e abbandonarmi un po’ allo sconforto, sentii improvviso uno scossone. Mi parve per un attimo che la lamiera sotto di me stesse per cedere e mi allarmai.
La realtà era ben diversa: il caruso senza nome che mi aveva sin lì aiutato in mille modi senza dubbio, salvandomi anche la vita in più occasioni, si stava adoperando adesso con tutta la forza che aveva in corpo per tirare a sé con vigorosi strattoni la fune metallica.
Ero già ad alcuni metri d’altezza, quando gridai il mio “No!”. Il pozzo verticale aveva già inglobato la cabina sulla quale mi trovato e quindi non ero più in grado di vedere il ragazzo. Ma potevo sentirlo e lui poteva sentire me. Così gridai con tutta la voce che potei, per sovrastare il fracasso dei metalli che stridevano: “Devi salire anche tu con me!”
“No!” mi rispose, con la voce contratta dallo sforzo immane.
“Come ti chiami?” chiesi, senza sapere nemmeno il perché.
“Liddu” era il suo nome, o almeno così mi parve di capire.
“Grazie, Liddu!” urlai in cambio, pur sapendo che difficilmente avrebbe potuto ancora sentire la mia voce, vista la rapidità con la quale l’ascensore risaliva il pozzo e visto il fragore crescente e gli echi che come schianti percuotevano l’aria buia.
Non mi restò altro da fare che attendere il termine della risalita.
E quando, dopo diversi minuti e dopo aver superato decine di livelli della miniera, l’ascensore si fu arrestato di colpo con uno schianto, non ci pensai due volte a saltare fuori.
I miei piedi toccavano di nuovo la pietra, mentre alle mie spalle l’ascensore ricadeva nel vuoto del pozzo, seguito da un’ecatombe di tuoni che mi sembrò durare in eterno.
Rimasi un attimo in silenzio, guardandomi attorno per vedere se esistesse un modo di controllare quel dannato ascensore. Desideravo farlo risalire con a bordo il mio salvatore. Ma dovetti accettare che non era possibile, perché non c’era alcun modo di manovrare quel cavo d’acciaio, che si limitava a scavallare la carrucola e da lì tornava diritto giù in fondo senza passare per un secondo argano o per qualsivoglia marchingegno o ruota o gancio o… Niente.
La via da seguire era una e una sola, non c’era altro che potessi fare lì a parte trovare l’uscita.
M’incamminai quindi lungo questo ennesimo tunnel che mi si parava davanti. E quando, man mano che procedevo, vidi aumentare sulle pareti il numero di radici e muschi e quando di lì a poco fecero la prima comparsa alcune foglie di piante rampicanti, capii che il mio incubo volgeva al termine.
L’aria si era intanto alleggerita di quel pulviscolo sulfureo che avevo respirato per tutto il tempo. Sentii infine anche il frinire di grilli e cicale e vidi un chiarore biancastro provenire dal fondo del tunnel. Così, mentre il passaggio si restringeva, spensi la torcia e mi accorsi che potevo vederne l’uscita.
Se avessi avuto ancora un briciolo di energia avrei corso e gridato e riso. Ma mi trovavo in uno stato di stanchezza tale che sentivo i muscoli liquefarsi e il respiro grattarmi nella gola prosciugata e nei polmoni pieni di terra. L’unica cosa che mi rimaneva per uscire di lì era la forza di volontà.
Fui costretto a chinarmi e strisciare carponi per attraversare quello stretto passaggio di luce bianca. Dopodiché, alzando gli occhi, riconobbi la Luna fare capolino tra le larghe foglie di un albero di fico.
Mi limitai a fare qualche passo barcollante fuori dall’ombra dell’albero e subito mi lasciai cadere sulla terra gessosa, resa candida dalla luce lunare. Ero in superficie, finalmente guardavo la crosta terrestre dall’esterno e non più dall’interno. Ero naufragato nelle profondità di un mare di pietra ma adesso ero salvo.
Torna all’indice di questo racconto
14
Rendendomi conto all’improvviso che, per tutto il tempo del mio incredibile viaggio, non avevo minimamente prestato attenzione alle necessità del mio corpo, scaraventai lo zaino davanti a me. Quasi ruppi le cinghie nel gesto furioso di aprirle. E ne estrassi la borraccia e i panini che avevo portato per un pranzo che, per forza di cose, era saltato.
Bevvi e mangiai come solo un animale sa fare e poi corsi di nuovo verso l’albero di fico… per pisciarci su.
Dopodiché, con passi molto lenti mi avviai verso il paese, ridendo tra me e me al solo pensiero di come sarei stato preso per pazzo quando mi fossi messo a raccontare le tante cose che mi erano capitate, le cose folli che avevo visto.
Sulla via di casa approfittai di tutta l’aria pulita, aria di libertà, che potevo infilare nei polmoni. Ma anche ebbi il tempo di godere della visione di una campagna che sembrava spandere una luce propria. Dopo tutte quelle ore nelle tenebra che non conosce fine, i bagliori che la Luna accendeva sulla trazzera, tempestata di cristalli di gesso, mi parvero come se parte del cielo stellato fosse sceso a darmi il benvenuto stendendosi ai miei piedi come un tappeto.
Risi ancora come uno scemo, da solo, ricordando che quei cristalli si chiamavano proprio “selenite”, la pietra della Luna. Ecco un’altra nozione delle tante che avevo assorbito negli anni, senza mai fermarmi a capirne davvero i significati nascosti, le conseguenze e le implicazioni sul mondo reale, sul passato dei miei antenati e sul mio presente e futuro.
Ero troppo stanco, stavo delirando.
Quando arrivai a casa dai nonni, era quasi l’alba e riuscii a togliermi di dosso i vestiti polverosi e a gettarmi sul letto senza svegliare nessuno.
Quando mi svegliai molte ore dopo raccontai loro di come il giorno prima, stupidamente, mi fossi addormentato all’ombra di un albero di fico, perdendo la cognizione del tempo e facendo sogni davvero strani.
La nonna si preoccupò che non avessi preso un’insolazione e mi tastò la fronte in cerca di febbre. Mentre il nonno rideva sotto i baffi, ricordando a voce alta di quella volta che da bambino s’era perso dopo una giornata di lavoro nei campi ed era stato costretto a passare la notte raggomitolato in una nicchia nella pietra, proprio vicino un albero di fico.
“Peccato che ancora non è stagione” aggiunse. “Avresti potuto raccogliere qualche fico. Alla nonna piacciono un sacco. Bisognerà tornarci tra qualche settimana.”
Io mi limitai a fissarlo con gli occhi sgranati e dopo un po’ risposi: “Sì, devo tornare laggiù. L’ho promesso.”
Fine | Torna all’indice di questo racconto
oppure
